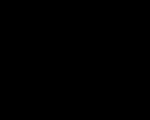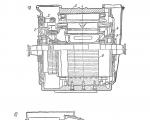Progresso e regressione. Criteri di progresso
Il progresso è inteso come una direzione di sviluppo, caratterizzata dal progressivo movimento della società da forme di organizzazione sociale inferiori e più semplici a forme più elevate e complesse. Il concetto di progresso si oppone al concetto di regressione, che è caratterizzato da un movimento inverso: dal più alto al più basso, degrado, ritorno a strutture e relazioni già obsolete. L'idea dello sviluppo della società come processo progressivo è apparsa nei tempi antichi, ma alla fine si è formata nelle opere degli illuministi francesi (A. Turgot, M. Condorcet, ecc.) - Hanno visto nello sviluppo il criterio del progresso della mente umana, nella diffusione dell’illuminazione. Una visione così ottimistica della storia cambiò nel XIX secolo. idee più complesse. Pertanto, il marxismo vede il progresso nella transizione da una formazione socioeconomica a un'altra, più elevata. Alcuni sociologi consideravano l'essenza del progresso la complicazione della struttura sociale e la crescita dell'eterogeneità sociale. Nella sociologia moderna, il progresso storico è associato al processo di modernizzazione, cioè al passaggio da una società agraria a una industriale, e poi a una postindustriale.
È ovvio che lo sviluppo progressivo della società non esclude movimenti di ritorno, regressioni, vicoli ciechi della civiltà e persino crolli. Ed è improbabile che lo sviluppo dell'umanità stessa abbia un carattere inequivocabilmente lineare; in esso sono possibili balzi in avanti accelerati e ritorni indietro. Inoltre, il progresso in un ambito delle relazioni sociali può essere accompagnato e addirittura causare una regressione in un altro. Lo sviluppo di strumenti e le rivoluzioni tecniche e tecnologiche sono una chiara prova del progresso economico, ma hanno portato il mondo sull'orlo di un disastro ambientale e hanno esaurito le risorse naturali della Terra. La società moderna è accusata di declino della moralità, crisi familiare e mancanza di spiritualità. Anche il prezzo del progresso è alto: le comodità della vita cittadina, ad esempio, sono accompagnate da numerose “malattie dell’urbanizzazione”. A volte i costi del progresso sono così alti che sorge spontanea la domanda: è possibile parlare di un progresso dell’umanità?
K. Marx ha ridotto lo sviluppo sociale al progresso nella sfera della produzione. Considerava progressiste solo quelle relazioni sociali che corrispondevano al livello delle forze produttive e aprivano spazio allo sviluppo dell'uomo (come principale forza produttiva). L'applicabilità di tale criterio è contestata nella scienza sociale moderna. Lo stato della base economica non determina la natura dello sviluppo di tutte le altre sfere della società. Lo scopo, e non il mezzo, di qualsiasi progresso sociale è creare le condizioni per lo sviluppo globale e armonioso dell’uomo.
Di conseguenza, il criterio del progresso dovrebbe essere la misura della libertà che la società è in grado di fornire a un individuo per massimizzare il suo potenziale. Il grado di progressività di un particolare sistema sociale deve essere valutato dalle condizioni in esso create per soddisfare tutti i bisogni dell'individuo, per il libero sviluppo dell'uomo (o, come si dice, dal grado di umanità del sistema sociale) .
Biglietto 6
Problemi globali del nostro tempo e modi per risolverli.
I problemi globali sono problemi sorti nella seconda metà del XX secolo. davanti a tutta l'umanità, dalle cui decisioni dipende l'esistenza di quest'ultima.
1. Il problema di prevenire una nuova guerra mondiale. La ricerca di modi per prevenire i conflitti mondiali iniziò quasi immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale e la vittoria sul nazismo.
Oggi possiamo affermare che la probabilità di un conflitto tra le principali potenze mondiali è molto inferiore rispetto a prima. Tuttavia, esiste la possibilità che le armi nucleari cadano nelle mani di regimi totalitari e reazionari o nelle mani di singoli terroristi.
2. Il problema del superamento della crisi ambientale e delle sue conseguenze. Questo problema è il più urgente. Nel corso della sua attività economica, l'uomo ha a lungo occupato la posizione di consumatore rispetto alla natura, sfruttandola senza pietà, credendo che le riserve naturali siano inesauribili. Uno dei risultati negativi dell’attività umana è stato l’esaurimento delle risorse naturali e l’inquinamento ambientale. Di conseguenza, sostanze pericolose per la vita e la salute umana furono rilasciate nell'atmosfera, distruggendola e finendo nel suolo. Non solo l'aria e la terra erano inquinate, ma anche le acque degli oceani. Ciò porta sia alla distruzione (estinzione) di intere specie di animali e piante, sia al deterioramento del patrimonio genetico di tutta l’umanità. Nel 1982, le Nazioni Unite hanno adottato un documento speciale, la Carta mondiale sulla conservazione, e successivamente hanno creato una commissione speciale sull'ambiente e lo sviluppo.
3. Il problema della crescita demografica. È associato al continuo aumento delle dimensioni della popolazione che vive sul pianeta. Nel 1990, il suo numero era di 5,3 miliardi di persone. Tuttavia è evidente che le risorse della Terra (in primis il cibo) sono limitate, e già oggi diversi paesi si trovano ad affrontare il problema di limitare la natalità.
4. Il problema del divario nel livello di sviluppo economico tra i paesi sviluppati dell'Occidente e i paesi in via di sviluppo del “terzo mondo” (il problema “Nord-Sud”). L'essenza di questo problema è che la maggior parte di quelli rilasciati nella seconda metà del 20° secolo. Dalla dipendenza coloniale dei paesi, avendo intrapreso la strada del recupero dello sviluppo economico, non sono stati in grado, nonostante i relativi successi, di raggiungere i paesi sviluppati in termini di indicatori economici di base (principalmente in termini di PNL pro capite). Ciò è dovuto in gran parte alla situazione demografica: la crescita della popolazione in questi paesi ha infatti compensato i successi economici ottenuti.
Tutti i problemi globali sono interconnessi. È impossibile risolverli separatamente, isolandoli dagli altri, attraverso gli sforzi di diversi paesi. Sono necessarie la volontà e le azioni di tutta l’umanità.
P. Nisbet: l'idea di progresso
I filosofi domestici, in sostanza, smisero di lavorare sui problemi del progresso sociale, così come su molti altri importanti problemi della filosofia sociale. Sebbene in Occidente questi ultimi siano ancora al centro di ricercatori seri, tra cui l'eminente teorico americano del progresso sociale Robert Nisbet. Nel 2007, il suo libro “Progresso: la storia di un'idea” è stato pubblicato in traduzione russa (è stato pubblicato in inglese nel 1980). Si tratta di uno studio fondamentale (il volume del libro è di 556 pagine), dedicato a uno dei problemi più importanti e urgenti della filosofia sociale, soprattutto nel nostro tempo, in cui l'umanità si trova in una profonda crisi e la stragrande maggioranza degli scienziati sociali rifiutano categoricamente non solo lo sviluppo progressivo della società, ma anche l’idea stessa di progresso.
Già nell'introduzione, Nisbet sottolinea: “... l'idea di progresso presuppone che l'umanità abbia migliorato la sua condizione in passato (da qualche stato primitivo di primitività, barbarie o addirittura insignificanza), continua a muoversi in questa direzione ora e continuerà ad andare oltre nel prossimo futuro.”
R. Nisbet inizia la formazione e lo sviluppo dell'idea di progresso fin dall'epoca antica. Allo stesso tempo, presta particolare attenzione al progresso spirituale (la crescita della conoscenza, lo sviluppo della scienza e della cultura, ecc.), il che è abbastanza comprensibile, dal momento che i ricercatori pre-marxisti della teoria del progresso, per ragioni oggettive, ignoravano il fattore economico, il cui ruolo determinante nello sviluppo sociale è stato dimostrato da K.Marx.
Il lavoro di Nisbet è composto da nove capitoli. Ci soffermeremo molto brevemente su ciascuno di essi, poiché è poco noto a una vasta gamma di lettori di letteratura filosofica.
Il filosofo americano inizia il suo studio (il primo capitolo) con una presentazione delle opinioni di Esiodo, come lui stesso definisce, un “filosofo contadino” vissuto alla fine dell'VIII secolo. AVANTI CRISTO e. Di tutte le opere di Esiodo, la poesia “Le opere e i giorni” attira un'attenzione particolare, in cui, secondo Nisbet, viene proposta l'idea di un cambiamento coerente di epoche di natura progressiva. Le idee di progresso, continua Nisbet, furono illuminate anche nelle opere di Eschilo, Protagora, Tucidide, Platone, Aristotele e altri pensatori dell'antica Grecia.
Nel secondo capitolo, l'autore esamina le opinioni dei primi cristiani. Nisbet esprime il proprio contributo, soprattutto quello di sant'Agostino: «Allo stesso tempo, i filosofi cristiani, a partire da Eusebio e Tertulliano per finire con sant'Agostino, che portarono la dottrina alla sua forma più sviluppata, divenuta classica, introdussero nuovi elementi nell'idea di progresso che lo dotò di un potere spirituale sconosciuto ai loro predecessori pagani. Intendo concetti e concetti come l'unità umana universale, la necessità storica, l'idea di progresso come dispiegamento nei secoli di un certo disegno che esiste dall'inizio dei tempi e, ultimo ma non meno importante, la fiducia nel futuro , fiducia che aumenterà nel tempo e tutto si riferisce più a questo mondo che all'altro mondo. A queste caratteristiche se ne dovrebbe aggiungere un'altra, vale a dire l'accento posto sul graduale e costante miglioramento spirituale dell'umanità. Questo processo trova infine espressione nell’avvento dell’età dell’oro della felicità, il regno millenario di Cristo che ritorna a governare la terra”. Non si può che essere d'accordo con questa conclusione di Nisbet. È stato il Beato Agostino che, nel linguaggio del cristianesimo, ha presentato l'intera storia come un processo che si sviluppa lungo una linea ascendente.
Il terzo capitolo è dedicato ai pensatori medievali. Molti ricercatori del Medioevo ritengono che questa fosse un'era di declino della cultura spirituale nel senso ampio del termine. Ad esempio, il filosofo francese del XVIII secolo. J. A. Condorcet sosteneva che il Medioevo fosse un'era di declino. La mente umana, essendo salita all'apice del progresso, iniziò a discenderne rapidamente. Ovunque regnavano l'ignoranza e la ferocia, e prevalevano gli inganni superstiziosi. La vittoria dei barbari sui romani e il dominio della religione cristiana portarono al fatto che la filosofia, l'arte e la scienza cessarono di svilupparsi e migliorare in modo creativo. A differenza di Condorcet e dei suoi sostenitori, R. Nisbet ritiene che nel Medioevo si attribuisse grande importanza allo sviluppo della cultura, alla comprensione filosofica della storia, ecc. Giovanni Duns Scoto, ad esempio, sosteneva che ci sono tre grandi epoche nella storia: la la prima è l'era della Legge (Antico Testamento), la seconda è l'era dello spirito (Nuovo Testamento) e la terza è l'era della verità.
Il quarto capitolo esamina il Rinascimento. Qui vengono presentate le opinioni di N. Machiavelli, Erasmo da Rotterdam, T. More, F. Bacon e R. Descartes. R. Nisbet sostiene che per Machiavelli il processo storico presenta alti e bassi. In linguaggio moderno possiamo dire che Machiavelli fu un sostenitore della teoria del ciclo storico. Credeva che il mondo non cambiasse, fosse sempre lo stesso.
Erasmo da Rotterdam, scrive Nisbet, come Machiavelli, rifiutava l'idea del progresso sociale. Anche Tommaso Moro, secondo l'autore del libro, non riconosceva l'idea di progresso sociale. È difficile essere d'accordo con questo. È del tutto possibile che More nella sua opera “Utopia” ignori il problema del progresso sociale, tuttavia, il modello della società futura da lui proposto indica che il filosofo sociale inglese consente implicitamente lo sviluppo progressivo della società.
Francis Bacon, continua R. Nisbet, non rifiutava la teoria del progresso sociale, ma aveva un atteggiamento estremamente negativo nei confronti del Medioevo. Quanto a Cartesio, secondo Nisbet non attribuiva alcuna importanza ai problemi del progresso sociale.
Nel quinto capitolo, il filosofo americano esamina l’idea di progresso alla luce della Riforma. “Qualunque cosa possano dire gli studiosi storici, la Riforma fu uno dei più grandi risvegli religiosi della storia”. Le opinioni di J.-B. sono presentate in dettaglio. Bossuet, G. Leibniz, G. Vico e altri scienziati.
Dal XVIII secolo, scrive Nisbet, inizia il trionfo dell'idea di progresso. "Tra il 1750 e il 1900 l'idea di progresso raggiunse il suo apice nel pensiero occidentale sia negli ambienti pubblici che in quelli scientifici." L'autore ha elencato noti pensatori europei di quel periodo: A. Turgot, J. A. Condorcet, A. Saint-Simon, O. Comte, G. W. F. Hegel, K. Marx e G. Spencer. Loro, dice R. Nisbet, collegavano il progresso con la libertà. A questo possiamo aggiungere quello non solo con la libertà, ma anche con l’uguaglianza e la giustizia. Rivoluzione francese del XVIII secolo. lanciare lo slogan: “Liberté, fraternité, égalité!” (“Libertà, fraternità, uguaglianza!”).
L'autore del libro evidenzia due aspetti del progresso del periodo in esame: il progresso come libertà e il progresso come potere, di cui si occupa il sesto capitolo. Dal suo punto di vista, progresso e libertà furono considerati insieme da Turgot, Condorcet, Kant e altri, prima di tutto analizza le opinioni di Turgot, il cui merito, a suo avviso, sta nel fatto che nel XVIII secolo. solo lui considerava inestricabilmente progresso e libertà.
Il settimo capitolo analizza il progresso come potere. Il campo visivo dell'autore comprende le idee degli utopisti, Rousseau, Comte, Marx, Herder, Hegel e altri. Vorrei citare una profonda affermazione di Nisbet su Marx: "Da nessuna parte Marx", scrive, "ci mostra un immagine di una società ideale che potrebbe essere paragonata a quella proposta da Comte e da molti altri utopisti del suo secolo. Marx espresse pubblicamente il suo disprezzo per tutte le forme di socialismo “utopico”, sia sotto forma di progetti che di soluzioni concrete, come nel caso dei sogni e dei calcoli americani di Etienne Cabet e Charles Fourier. Ma ciò non smentisce in alcun modo il profondo interesse di Marx per la futura età dell’oro”. Parole d'oro. Nella nostra epoca sovietica, i cosiddetti comunisti scientifici sostenevano che il comunismo è una società ideale alla quale dobbiamo tendere. Nel frattempo, ne L'ideologia tedesca, K. Marx e F. Engels scrivono direttamente: “Il comunismo per noi non è uno Stato che deve essere fondato, non un ideale al quale la realtà deve conformarsi. Chiamiamo comunismo un movimento reale che distrugge lo stato attuale."
R. Nisbet dedica l'ottavo capitolo ai problemi della delusione in atto all'inizio del XX secolo. Per un secolo e mezzo (1750-1900) tutti credevano nell’idea del progresso sociale, ma questa convinzione venne scossa con l’avvento del XX secolo. Tuttavia, c’erano ricercatori che non rifiutavano completamente la teoria del progresso. E tra questi, un posto speciale è occupato dallo scienziato americano T. Veblen, autore del noto libro "La teoria della classe ricreativa". Nisbet scrive che "Veblen fu molto presto affascinato dalle teorie dello sviluppo associate a Hegel, Marx e molti antropologi inglesi".
L’ultimo (nono) capitolo si chiama “Progress at a Dead End”. L'autore stesso spiega questo nome come segue: “Sebbene il XX secolo non sia privo di fiducia nel progresso, ci sono tuttavia seri motivi per credere che quando gli storici alla fine inseriscono il nostro secolo nella classificazione finale, uno dei principali segni del XX secolo non sarà fede, ma, al contrario, un rifiuto della fede nell’idea di progresso. Lo scetticismo nei confronti del progresso, che nel XIX secolo era appannaggio di un piccolo gruppo di intellettuali occidentali, si è diffuso nell’ultimo quarto del XX secolo ed è oggi condiviso non solo dalla stragrande maggioranza degli intellettuali, ma anche da milioni di comuni occidentali. .” Tutto questo è vero, ma non abbastanza completo. La ragione principale della delusione nel progresso è il modo di produzione capitalistico a partire dalla fine del 19° secolo. sta attraversando una profonda crisi sistemica, che ha portato a due guerre mondiali che sono costate la vita a milioni di persone e hanno rallentato per decenni lo sviluppo dell’umanità.
Critici del progresso sociale
Tocchiamo anzitutto alcune questioni metodologiche e confrontiamo a questo proposito i concetti di “cambiamento”, “sviluppo” e “progresso”. Sebbene siano spesso usati come sinonimi, non devono essere confusi. Si noti che L.P. Karsavin ha anche attirato l'attenzione sul fatto che molti spesso li confondono. Ha definito il cambiamento come segue: “…il cambiamento è un sistema di relazioni tra elementi spazialmente separati che cambia continuamente nel tempo”. Senza cambiamento non c'è nulla. Tutti i processi naturali e sociali sono in uno stato di costante cambiamento. Ma non tutti i cambiamenti portano allo sviluppo, tanto meno al progresso. Ciò richiede la presenza di condizioni adeguate. Il concetto di “cambiamento” ha una portata più ampia rispetto ai concetti di “sviluppo” e “progresso”. Ogni sviluppo e ogni progresso presuppongono un cambiamento, ma non tutti i cambiamenti, come già notato, portano necessariamente al progresso o allo sviluppo. Per quanto riguarda il rapporto tra i concetti di “sviluppo” e “progresso”, il concetto di sviluppo è più ampio del concetto di progresso. Ogni progresso è associato allo sviluppo, ma non tutto lo sviluppo è progresso. A questo proposito, va notato che la definizione di progresso come processo irreversibile necessita di chiarimenti. Il fatto è che questa definizione è applicabile allo sviluppo progressivo, mentre lo sviluppo regressivo necessita di una caratteristica diversa. Lo sviluppo progressivo è associato a cambiamenti fondamentali e qualitativi, con il passaggio da un livello di qualità inferiore a uno superiore. Lo sviluppo regressivo è agli antipodi dello sviluppo progressivo.
Il concetto di progresso è applicabile solo alla società umana. Per quanto riguarda la natura vivente e inanimata, in questo caso dovrebbero essere utilizzati i concetti di “sviluppo”, “evoluzione” (natura vivente) e “cambiamento” (natura inanimata). Associare il progresso nella natura vivente con l'adattamento degli organismi alle condizioni esterne, come talvolta viene fatto, per usare un eufemismo, non è del tutto corretto, perché il progresso è caratterizzato da uno sviluppo verso l'alto, una transizione dal inferiore al superiore, e l'adattamento non necessariamente implicano uno sviluppo progressivo. Quindi, dal mio punto di vista, il concetto di progresso non è universale ed è applicabile solo alla vita sociale.
K. Marx è stato il primo a rivelare scientificamente l'essenza del progresso sociale. Ha sottolineato che il concetto di progresso non può essere preso nella solita astrazione, che è sempre necessario analizzare concretamente il movimento progressivo della società e non costruire costruzioni speculative. Marx ha dimostrato che ogni progresso deve essere visto attraverso le forze produttive che costituiscono la base di tutta la storia umana. È la crescita e il miglioramento delle forze produttive che mostra lo sviluppo verso l’alto della società umana. Il passaggio da una formazione socioeconomica a un'altra, più elevata, non è altro che un salto qualitativo, cioè progressivo, nello sviluppo dell'umanità. Allo stesso tempo, Marx si oppose categoricamente ad una visione lineare del progresso della società. Ha sottolineato che l’umanità si sta sviluppando in modo non uniforme e che questo sviluppo non è monolineare, ma multilineare.
Il progresso sociale è il passaggio da forme meno perfette di organizzazione dell'attività umana a forme più perfette, lo sviluppo progressivo dell'intera storia mondiale. Il progresso non può essere ridotto solo a cambiamenti quantitativi. Naturalmente sono impliciti, ma per il progresso sociale la caratteristica principale sono i cambiamenti qualitativi. Il passaggio dal vecchio al nuovo è preparato dall'intero corso della storia precedente. I prerequisiti per l'emergere del nuovo sono già nel profondo del vecchio, e quando la struttura del vecchio si restringe per il nuovo, si verifica un salto nello sviluppo della società. Può essere sia di natura evolutiva che rivoluzionaria. In generale bisogna dire che le rivoluzioni costituiscono un'eccezione, mentre il percorso evolutivo del progresso è una forma naturale di sviluppo ascendente della società.
L’umanità migliora continuamente e si muove lungo il percorso del progresso sociale. Questa è una legge universale della società. Ma da ciò non consegue affatto che non vi sia alcuna regressione nel suo sviluppo, né, per così dire, movimenti retrogradi, che tutti i paesi e le regioni del nostro pianeta si stiano sviluppando in modo uniforme, allo stesso ritmo e, per così dire, con calma galleggiando con il flusso della storia. Ma la storia è un processo complesso e contraddittorio. È il prodotto dell'attività di milioni di persone, c'è una lotta tra il nuovo e il vecchio, e ci sono periodi in cui il nuovo viene sconfitto, a seguito dei quali lo sviluppo sociale fa enormi passi indietro. In altre parole, progresso e regresso coesistono, o meglio, fianco a fianco. Inoltre, va tenuto presente che il progresso sociale non è lineare, ma di natura pluralistica, cioè lo sviluppo progressivo della società non procede in modo uniforme, ma in modo diverso. I progressi vengono compiuti in modo diverso nei diversi paesi e regioni, a seconda delle specifiche condizioni socioeconomiche. Alcuni popoli si trovano al vertice della piramide sociale, mentre altri si trovano alla base. Non dobbiamo dimenticare che la storia è drammatica, e talvolta anche tragica, e che il progresso viene spesso raggiunto a costo della vita di centinaia di migliaia di persone. Le piramidi egiziane, ad esempio, testimoniano l'enorme successo della civiltà egizia, ma durante la loro costruzione morirono migliaia di persone. Naturalmente puoi protestare contro tale progresso, ma poi devi protestare contro la storia in generale o fermarla al livello di uno stato primitivo, che alla fine porterà alla sua morte naturale.
Lo studio del progresso sociale richiede la considerazione della sua struttura, perché l'analisi strutturale arricchisce le nostre idee sullo sviluppo progressivo dell'umanità. Ci sembra che nella struttura del progresso sociale si possano distinguere due elementi: oggettivo e soggettivo.
L'elemento oggettivo sono le condizioni oggettive della società, che comprendono i rapporti materiali delle persone, le forze produttive, i rapporti di produzione - in una parola, tutti quei fenomeni della vita sociale che non dipendono dalla volontà delle persone. Lo sviluppo del processo storico è oggettivo e inevitabile; nessuno può fermare il movimento ascendente della società.
Ma il progresso sociale è impensabile senza un elemento soggettivo, cioè senza l'attività delle persone che creano la propria storia e perseguono obiettivi consapevolmente fissati. Il progresso sociale dipende in gran parte dall'attività delle persone, dalla loro attenzione e dal desiderio di cambiare in meglio l'ordine esistente, per creare le condizioni necessarie per la manifestazione delle forze essenziali dell'uomo. Sebbene il fattore soggettivo sia determinato da condizioni oggettive, tuttavia, come tutti i fenomeni sociali, ha una relativa indipendenza, espressa in presenza di una logica interna di sviluppo e di un'influenza significativa sull'elemento oggettivo del progresso sociale.
Un problema urgente nella teoria del progresso sociale è chiarirne i criteri. Il criterio dovrebbe essere oggettivo e non valutativo. Se ci avviciniamo al criterio del progresso sociale dal punto di vista dell'assiologia (molti lo fanno), allora, in sostanza, sarà impossibile trovare un tale criterio, perché ciò che è progressivo per uno potrebbe rivelarsi regressivo per un altro ; ciò che è bene per uno è bene per un altro, l'altro è male. E l'oggettività del criterio può essere rivelata sulla base di indicatori oggettivi, cioè indicatori che dipingono un quadro oggettivo della società. Il principale criterio oggettivo del progresso sociale è la crescita delle forze produttive. La scoperta di questo criterio appartiene a K. Marx. Dal suo punto di vista, lo sviluppo delle forze produttive nel tempo porta a un cambiamento nei rapporti di produzione e quindi a una transizione verso un livello più elevato di sviluppo sociale.
Sebbene, come scrive R. Nisbet, la fede nel progresso sociale accompagni l'umanità da millenni, è tuttavia impossibile non notare che i problemi del progresso cominciarono a dominare la vita spirituale dell'Europa a partire dalla seconda metà del XVIII secolo. fino alla fine del XIX secolo, cioè centocinquanta anni. Ma già alla fine del XIX secolo, quando tutte le contraddizioni della società borghese cominciarono ad apparire in rilievo, quando essa cominciò ad affrontare profondi fenomeni di crisi, l’idea di progresso cominciò ad essere criticata. E nel 20 ° secolo. Sempre più ricercatori iniziarono a dubitare del progresso ascendente della società umana. Ma la critica al progresso sociale si è intensificata soprattutto nella seconda metà del XX secolo. In Francia, dove si è sempre creduto che l’umanità si sviluppasse in linea ascendente, improvvisamente si cominciò a parlare del fatto che il progresso era morto e il suo cadavere avvelenava l’atmosfera. J. Lacroix, C. Sedillo, M. Friedman e altri iniziarono a sostenere che l'umanità cominciò a decomporsi. Postmodernisti J. Deleuze, M. Ser, J.-F. Lyotard e altri attribuirono la responsabilità di tutti i problemi moderni al razionalismo classico e all’Illuminismo, che predicava la fede in un progresso sociale senza fine. Negli Stati Uniti W. Pfaff ha annunciato che l’idea di progresso è morta e che non è necessario farla rivivere. D. Bell ha espresso forti dubbi sul fatto che l'umanità si stia sviluppando, poiché i paesi arretrati restano sempre più indietro. “In Africa negli anni Ottanta”, scrive, “si viveva peggio che in Africa negli anni Settanta, e in Africa negli anni Novanta era peggio che in Africa negli anni Ottanta...”.
Il più grande filosofo francese moderno R. Aron nelle sue prime opere riconobbe il progresso, ma lo ridusse ad accumulazioni puramente quantitative. “…Alcuni tipi di attività umana”, scriveva, “hanno un carattere che non può non essere riconosciuto come superiorità del presente sul passato e del futuro sul presente. Si tratta di tipi di attività umana, i cui prodotti si accumulano o i cui risultati sono quantitativi. La storia dell'umanità contiene un momento di conservazione; non è solo trasformazione. Si presuppone che le persone abbiano istituzioni sociali diverse, che creino e che queste istituzioni sociali e le creazioni delle persone siano preservate. La storia esiste perché la preservazione dei risultati dell'attività umana pone alle diverse generazioni la questione se accettare o rifiutare l'eredità passata. In vari ambiti della vita, il ritmo del futuro dipende dalla natura della risposta di ciascuna generazione al suo atteggiamento nei confronti dei risultati delle generazioni precedenti. Preservare l’eredità del passato ci permette di parlare di progresso solo nel caso in cui la nuova generazione non solo preservi l’esperienza precedente, ma vi aggiunga qualcosa di proprio”.
R. Aron considera il problema del progresso sociale da un punto di vista puramente quantitativo. In questo senso, non nega la crescita dell’economia, l’aumento del ritmo del suo sviluppo, né i cambiamenti nella struttura stessa dell’economia, ma rifiuta categoricamente qualsiasi progresso nel campo delle relazioni industriali e della struttura politica.
Nelle sue ultime opere, Aron ha generalmente espresso una critica assoluta al progresso sociale. Nel suo libro “La disillusione del progresso” ha affermato senza mezzi termini che ciò che sta accadendo in tutto il mondo non è progresso, ma regressione. A questo proposito, il filosofo analizza i problemi della dialettica di uguaglianza, socializzazione e universalità.
Considerando le questioni di uguaglianza nel mondo moderno, R. Aron osserva che l'ideale di uguaglianza, promosso dalle teorie sociali in passato, si è infatti rivelato falso e utopico. Il mondo moderno dimostra una crescente disuguaglianza di classe e una crescente polarizzazione sociale delle persone. I conflitti razziali e nazionali non diminuiscono e questi ultimi si verificano non solo nei paesi arretrati, ma anche in quelli sviluppati.
Per quanto riguarda la dialettica della socializzazione, Aron si riferisce principalmente allo stato attuale della famiglia e della scuola. Considerando la famiglia, lo scienziato osserva che, a differenza delle epoche passate, nella famiglia moderna c'è più uguaglianza tra marito e moglie, genitori e figli, che non può che essere valutata positivamente. Ma allo stesso tempo si osservano fenomeni estremamente negativi per la famiglia. Quindi, non appena i bambini crescono, iniziano a vivere separatamente dai loro genitori e spesso li dimenticano del tutto, il che alla fine rompe i legami tra generazioni e senza tali connessioni la società nel suo insieme non può funzionare normalmente. “La famiglia perde sempre più le sue funzioni economiche... Creata sulla base della libera volontà di due persone, risulta fragile e instabile...”. Le donne, continua il filosofo francese, reclamano un’uguaglianza non formale, ma reale. Ma l’idea di uguaglianza tra uomini e donne non è solo un problema sociale, ma anche un problema legato alle differenze naturali tra uomini e donne. Le ragazze vogliono fare lo stesso lavoro dei ragazzi, anche se dal punto di vista delle differenze di genere questo lavoro può essere controindicato per le ragazze. Aron ritiene che col tempo ciò potrebbe portare non solo al degrado della famiglia, ma anche allo spopolamento della società. L'anomia e l'alienazione si osservano ovunque, la solitudine e l'incertezza sul futuro sono ovunque.
Analizzando la dialettica dell'universalità, R. Aron osserva che per la prima volta l'umanità vive in un unico spazio storico. “Da un lato le Nazioni Unite, dall’altro i Giochi Olimpici simboleggiano una certa unità dell’umanità”. Ma allo stesso tempo, continua Aron, si verifica una disintegrazione della società. La civiltà moderna non distrugge le relazioni interstatali, ma viola gli interessi nazionali dei diversi popoli. Il mondo si sta sviluppando in modo disomogeneo, alcuni stati hanno un potente potenziale economico, mentre altri sono privati dei più moderni strumenti di produzione. “Le persone non hanno mai conosciuto la storia che hanno fatto, ma ancor meno la conoscono oggi. È più facile pensare al futuro che crederci in anticipo. La storia resta umana, drammatica e quindi in un certo senso irrazionale." In una parola, conclude Aron, l'umanità sta scivolando verso il basso e non si può parlare di alcuno sviluppo verso l'alto.
Attualmente, in connessione con i processi di globalizzazione, la crisi del capitalismo è diventata ancora più acuta. La globalizzazione è iniziata dopo il crollo dell’URSS nel 1991. Prima di allora, il mondo sociale era diviso in tre settori: il mondo del socialismo, il mondo del capitalismo e il mondo dei paesi in via di sviluppo. Tutti gli Stati collaboravano tra loro, ma soprattutto difendevano i propri interessi nazionali in tutte le sfere della vita pubblica. Nella sfera economica, ogni Stato ha sviluppato la propria economia; nella sfera politica, la tutela dell’integrità territoriale e la preservazione della sovranità nazionale hanno avuto la priorità. Nella sfera spirituale, molta attenzione è stata prestata allo sviluppo della cultura nazionale.
Sono emersi due poli. Uno di questi era guidato dall’Unione Sovietica, l’altro dagli Stati Uniti d’America. Gli interessi di questi due poli, naturalmente, non coincidevano, ma avevano un obiettivo comune: prevenire una terza guerra mondiale.
Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la situazione nel mondo sociale è cambiata radicalmente. Il mondo bipolare è scomparso, rimane solo un polo. La globalizzazione è iniziata. Ma non è un processo oggettivo; ha distrutto la logica della storia. È imposto artificialmente e talvolta con la forza dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per proteggere i loro interessi nazionali e geopolitici. Come scrive il ricercatore americano N. Chomsky, “la globalizzazione è il risultato dell’imposizione forzata ai popoli del mondo da parte di governi potenti, in particolare quello degli Stati Uniti, di accordi commerciali e altri accordi progettati per rendere più facile per le aziende e i ricchi dominare le economie nazionali in assenza di obblighi nei confronti dei rappresentanti di queste nazioni”. Ed ecco cosa scrive lo scienziato inglese Z. Bauman: “... il concetto di “globalizzazione” è stato creato per sostituire il precedente concetto di “universalizzazione”, quando è diventato chiaro che la creazione di connessioni e reti globali non ha nulla a che fare con l’intenzionalità e la controllabilità, da essa implicite. Il concetto di globalizzazione descrive processi che sembrano spontanei, spontanei e disordinati, processi che avvengono al di là delle persone sedute al pannello di controllo, impegnate nella pianificazione e, inoltre, assumendosi la responsabilità dei risultati finali. Senza troppe esagerazioni, possiamo dire che questo concetto riflette la natura disordinata dei processi che si verificano a un livello separato da quel territorio “essenzialmente coordinato” che è governato da una legittima “autorità superiore”, cioè da Stati sovrani. In sostanza, nulla dipende dagli stati nazionali.
La globalizzazione sta distruggendo l’unità e la diversità della storia mondiale. Unifica, standardizza e primitivizza il mondo sociale, forma un’umanità di mercato, in cui prevale il principio hobbesiano della “guerra di tutti contro tutti”. La globalizzazione riguarda l’individualismo, non il collettivismo. La globalizzazione ha portato all’emergere di strutture sovranazionali economiche, finanziarie, politiche, legali e di altro tipo che prescrivono regole di comportamento e persino di stile di vita per tutti i popoli e gli stati. La globalizzazione è una sorta di “forno fusorio” nel quale vengono gettati più di sei miliardi della popolazione mondiale. Di questi sei miliardi di persone, solo il “miliardo d’oro” soddisfa più o meno i loro bisogni socialmente necessari. Il resto conduce un'esistenza miserabile. “Solo 358 miliardari possiedono la stessa ricchezza di 2,5 miliardi di persone messe insieme, quasi la metà della popolazione mondiale”.
La globalizzazione ha dato origine a una società dei consumi che rifiuta tutti i valori precedenti, ignora il passato storico ed è completamente disinteressata al suo futuro. La globalizzazione è una strada che non porta da nessuna parte.
Molti ricercatori occidentali della moderna società capitalista lo capiscono. Recentemente è stata pubblicata una monografia collettiva (autori sono i famosi scienziati I. Wallerstein, R. Collins, M. Mann, G. Derlugian e K. Calhoun) dal titolo “Does Capitalism Have a Future?” Autori nel collettivo Prefazione scrivi: "I prossimi decenni porteranno con sé cataclismi inaspettati e problemi colossali". Credono che dopo la fine della Guerra Fredda tutti si siano calmati, perché speravano che con il crollo del socialismo il capitalismo si sarebbe sviluppato in modo stabile e con successo. Ma ciò non è avvenuto.
Questo è vero. A rigor di termini, la Guerra Fredda non è mai finita e continuerà a peggiorare fino a quando le contraddizioni economiche, culturali e geopolitiche del mondo moderno non saranno risolte.
I. Wallerstein, in quanto creatore della teoria del sistema, ritiene che la macroeconomia moderna, basata sui principi capitalistici, si estinguerà. Pensa ingenuamente che “il capitalismo potrebbe finire con l’abbandono da parte degli stessi capitalisti di fronte al dilemma senza speranza di prosciugare le opportunità di investimento”. Ma allo stesso tempo crede che nessuno attualmente possa prevedere quale tipo di sistema sociale sostituirà quello capitalista.
R. Collins ripone tutte le sue speranze nella classe media. È sconvolto dal fatto che molti membri di questa classe stiano andando in rovina.
M. Mann non vede un possibile sostituto del capitalismo, ma sostiene soluzioni socialdemocratiche ai problemi della globalizzazione capitalista.
Come già notato, l'umanità si è sempre sviluppata in modo non uniforme. Questa è la logica del processo storico. Alcuni popoli si sono fatti avanti e poi sono usciti dalla scena storica. Al loro posto apparvero altre nazioni. La storia si è sviluppata localmente. Pertanto, le crisi di un particolare organismo sociale non hanno avuto un impatto particolare su altri paesi e stati. Ma a differenza delle epoche passate, la nostra è un’era caratterizzata da un unico spazio economico, politico, sociale, culturale e informativo. Pertanto, la crisi della società moderna non è locale, ma globale. Ma superare questa crisi è del tutto possibile. Per fare questo è necessario deglobalizzare la società moderna. È possibile? Si è possibile. Il fatto è che il processo storico è un'unità dell'oggettivo e del soggettivo. Obiettivo è la logica immanente dello sviluppo della società. Soggettivo: attività umana. Il primato appartiene all'obiettivo. È impossibile ignorare lo sviluppo storico-naturale dell'umanità e violare le leggi oggettive della società. Ma l’assolutizzazione dell’oggettivo porta al fatalismo, e l’assolutizzazione del soggettivo porta al volontarismo. Oggettivo e soggettivo sono dialetticamente interconnessi. Questo rapporto è stato brillantemente messo in luce da K. Marx: “Gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno come vogliono, in circostanze che non hanno scelto loro stessi, ma che sono immediatamente disponibili, date loro e trasmesse dalla passato."
Poiché le persone stesse creano la propria storia, possono correggerla durante questa creazione. E questo accade quotidianamente, se non ogni minuto. Per migliorare la propria vita, le persone fanno rivoluzioni, attuano riforme economiche, politiche, culturali e di altro tipo. Il processo storico è oggettivo, ma non fatale. Pertanto, la deglobalizzazione è del tutto possibile. Ciò richiede solo la volontà politica delle classi dominanti dell’Occidente. È necessario proteggere non i propri interessi egoistici, ma gli interessi di tutta l’umanità. Ciò significa un ritorno alla logica naturale, cioè oggettiva, dello sviluppo sociale.
I critici della teoria del progresso sociale ignorano l’unità di passato, presente e futuro. Nel frattempo, il processo storico è il passato, il presente come risultato del passato e il futuro come risultato del presente. Chi nega il futuro nega quindi il presente e il passato. Come scrive Carr, “La convinzione che veniamo da qualche parte è indissolubilmente legata alla convinzione che stiamo andando da qualche parte. Una società che non crede più di avanzare verso il futuro cessa presto di interessarsi al proprio sviluppo nel passato."
Se non c'è movimento in avanti, allora devi "calpestare l'acqua" o tornare indietro. Si esclude il “segnare il tempo” perché, come già osservato, le nuove generazioni con i loro nuovi bisogni si impegneranno ad andare avanti e a superare le difficoltà che si presenteranno loro. Anche il ritorno è escluso, perché, in senso stretto, non c'è nessun posto dove tornare. Resta quindi l'unica via d'uscita: superare le difficoltà, come prima, per passare da uno stato qualitativo della società a un altro, più progressista. Finché esisterà l’umanità, sarà necessario fare progressi. Questa è la logica immanente della storia, che non ha nulla in comune né con il fatalismo né con il volontarismo.
Andare avanti significa andare verso il socialismo. Ma a causa della temporanea sconfitta del socialismo, anche i ricercatori critici nei confronti del capitalismo hanno paura di pronunciare il termine “socialismo”. Nel frattempo, non c'è nulla di spaventoso in questa parola. Deriva dalla parola “socializzazione”. La socializzazione ha molti significati associati a una persona. In primo luogo, la socializzazione è umanizzazione. In secondo luogo, questo è lo sviluppo delle relazioni e delle connessioni sociali, in terzo luogo, questa è la formazione della società, in quarto luogo, questo è abituare il bambino alla squadra.
Dal momento in cui una persona nasce, la sua socializzazione avviene in una società, il cui tipo è determinato dal metodo di produzione della vita materiale. La socializzazione dell'uomo nella società borghese va avanti da quasi cinquecento anni. Durante questo periodo, l’umanità ha fatto un enorme passo avanti. Ma il modo di produzione borghese ha esaurito le sue possibilità di socializzazione umana. È giunto il momento per un altro modo di produzione: socialista. O la socializzazione socialista o la desocializzazione di una persona, cioè il ritorno ai propri antenati. A proposito, questo è del tutto possibile quando sono già evidenti molti segni di desocializzazione: individualismo assoluto, rafforzamento dell'irrazionalismo, deintellettualizzazione e primitivizzazione della società, predicazione dell'omosessualità, egoismo ingiustificato, lusso di una piccola manciata di persone e povertà di miliardi .
Ma sono ottimista e profondamente fiducioso che l’umanità supererà l’attuale situazione di crisi e si svilupperà verso l’alto, come è stato fino ad ora.
Chomsky N. Profitto in pubblico. M., 2002, pag. 19.
Bauman Z. Società individualizzata. M., 2002, pag. 43.
Martin G.-P., Schumann X. La trappola della globalizzazione. Un attacco alla prosperità e alla democrazia. M., 2001, pag. 46.
Wallerstein I., Collins R., Mann M., Derlugyan G., Calhoun K. Il capitalismo ha un futuro? M., 2015, pag. 7.
Proprio qui. Pag. 9.
Marx K., Engels F. Soch. T. 8. M., 1957. P. 119.
Carr E. N. Qu’est-ce que l’histoire? Parigi, 1988. P. 198.
Associativamente su "Modelli della storia mondiale dello sviluppo umano"
La storia moderna mostra chiaramente che lo sviluppo dell'uomo e della società non avviene. Ciò che viene definito Progresso è in realtà un processo completamente opposto - chiamato Regressione o Degrado - dell'Individuo, della famiglia, del clan, delle persone, dei Paesi, della Comunità umana nel suo insieme...
Vedi il doc. film - CASA. Racconto di viaggio (Director's cut) https://youtu.be/l-rnx85uPyQ
Sono nella Natura! - Col cuore mi tuffo...
Sopra di me c'è il cielo azzurro...
Mattina, pomeriggio - sera va...
IL PROGRESSO è:
- "(Latino progressus - movimento in avanti, successo) - la direzione dello sviluppo progressivo, che è caratterizzato da una transizione dal inferiore al superiore, dal meno perfetto al più perfetto.
L’idea dello sviluppo progressivo è entrata nella scienza come versione secolarizzata della fede cristiana nella provvidenza. Le aspirazioni bibliche dei profeti riflettevano l'immagine del futuro come un processo sacro, predeterminato e irreversibile di sviluppo umano, guidato dalla volontà divina.
Ma le origini di questa idea si trovano molto prima, nel greco antico. Filosofo tradizioni. Platone nelle “Leggi” e Aristotele nella “Politica” hanno discusso del miglioramento dell'organizzazione socio-politica, che si sviluppa dalla famiglia e dalla comunità primitiva fino a quella greca. politica (città-stato).
Un po' più tardi, nel Medioevo, R. Bacon tentò di utilizzare il concetto di P. in campo ideologico. Ha suggerito che la conoscenza scientifica, accumulandosi nel tempo, diventa sempre più migliorata e arricchita.
E in questo senso, ogni nuova generazione scientifica è in grado di vedere meglio e più lontano dei suoi predecessori. Le parole di Bernardo di Chartres sono ampiamente conosciute oggi: "Gli scienziati moderni sono nani che stanno sulle spalle dei giganti".
Nei tempi moderni, le forze trainanti della filosofia cominciarono a essere viste nelle scienze naturali. Secondo G. Spencer, la psicologia nella società, come in natura, è soggetta al principio universale dell'evoluzione: la complessità in continua crescita dell'organizzazione e del funzionamento interni.
A poco a poco, il concetto di P. si diffuse nello sviluppo della storia generale e fu introdotto nella letteratura e nell'arte. La diversità degli ordini sociali nelle diverse civiltà cominciò a essere spiegata dalle differenze nelle fasi di sviluppo progressivo.
È stata costruita una sorta di "scala Panish", in cima alla quale si trovano i paesi occidentali più sviluppati e civilizzati. società e inferiori a diversi livelli - altre culture, a seconda del livello del loro sviluppo. Il concetto di P. fu “occidentalizzato”, ponendo le basi per l’“eurocentrismo” e il “centrismo americano”.
Nei tempi moderni, il ruolo decisivo nello sviluppo progressivo cominciò ad essere assegnato all'Uomo. M. Weber ha sottolineato la tendenza generale alla razionalizzazione nella gestione dei processi sociali, E. Durkheim - la tendenza all'integrazione della società attraverso la “solidarietà organica”, che si basa sul contributo reciprocamente vantaggioso e complementare di tutti i membri della società.
Oggi è la volta dei secoli XIX-XX. è giustamente chiamato il “trionfo dell’idea di P.”, poiché in quel periodo uno spirito di romantico ottimismo accompagnava la generale fiducia che la scienza e la tecnologia potessero garantire il continuo miglioramento della vita sociale.
In generale, il concetto classico di P. può essere presentato come un'idea ottimistica della graduale liberazione dell'umanità dall'ignoranza e dalla paura nel cammino verso livelli di civiltà sempre più elevati e raffinati.
Si presumeva che tale movimento sarebbe continuato nel presente e nel futuro, nonostante le deviazioni occasionali. Era diffusa la convinzione che la prosperità potesse essere mantenuta a tutti i livelli, in tutte le principali strutture della società e, di conseguenza, la piena prosperità potesse essere raggiunta per tutti.
Si trattava della piena realizzazione di valori come la libertà, l’uguaglianza, la giustizia sociale e la prosperità economica. Il concetto classico si basava sul concetto di tempo lineare irreversibile, dove P. è una differenza valutata positivamente tra passato e presente o presente e futuro.
PRINCIPALI CRITERI DI PROGRESSO:
Tra i criteri di P., i più comuni erano:
- miglioramento della religione (Agostino, J. Buset),
- crescita delle conoscenze scientifiche (J.A. Condorcet, D. Vico, O. Comte),
- giustizia e uguaglianza (T. More, T. Campanella, K. Marx),
- la crescita della libertà individuale in concomitanza con lo sviluppo della moralità (I. Kant, E. Durkheim),
- dominio sulla natura (G. Spencer),
- sviluppo della tecnologia,
- industrializzazione, urbanizzazione (K.A. Saint-Simon).
CONTRADIZIONI E FENOMENI NEGATIVI DEL PROGRESSO:
Tuttavia, dopo la prima guerra mondiale, iniziarono ad essere espressi dubbi sulla progressività dello sviluppo sociale e iniziarono ad apparire idee sugli effetti collaterali negativi dello sviluppo sociale.
F. Tennis è stato uno dei primi a criticare la teoria di P..
Secondo lui:
- lo sviluppo della società da tradizionale, comunale a moderna, industriale non ha migliorato, ma ha peggiorato le condizioni della vita umana.
- Le connessioni sociali personali, dirette e primarie della società tradizionale sono state sostituite da contatti impersonali, indiretti, secondari, puramente strumentali della società moderna.
Dopo la seconda guerra mondiale, le critiche ai postulati di base della teoria di P. si intensificarono.
È diventato evidente a molti che P. in un'area porta a spiacevoli effetti collaterali in un'altra:
Lo sviluppo della scienza e della tecnologia, l'urbanizzazione, l'industrializzazione, accompagnati dall'inquinamento e dalla distruzione dell'ambiente, hanno portato a una crisi ambientale.
La fiducia nella necessità di una crescita economica e tecnologica costante ha lasciato il posto all’idea alternativa di “limiti alla crescita”.
Gli scienziati hanno calcolato che:
- se il livello di consumo nei diversi paesi si avvicina a quello occidentale. standard, il pianeta esploderà a causa del sovraccarico ambientale.
Il concetto del “miliardo d'oro”, secondo il quale solo un miliardo di persone provenienti da paesi ricchi può garantire un'esistenza sicura sul pianeta, ha finalmente minato il postulato principale del concetto classico di P.: l'orientamento verso un futuro migliore per tutta l'umanità.
Per molto tempo ha prevalso la convinzione della superiorità del percorso di sviluppo seguito dall'Occidente. la civiltà cedette il passo alla delusione.
Allo stesso tempo, è stato inferto un duro colpo al pensiero utopico, che rifletteva idee idealizzate su una società migliore.
Il sistema mondiale del socialismo è stato l’ultimo dei tentativi di attuare praticamente la visione utopica del mondo.
L’umanità non ha ancora in magazzino progetti orientati verso un futuro più luminoso, “capaci di catturare l’immaginazione umana e mobilitare l’azione collettiva (il ruolo che le idee socialiste hanno svolto così efficacemente);
- abbiamo invece o profezie catastrofiche,
- o semplici estrapolazioni delle tendenze attuali (come, ad esempio, nelle teorie della società postindustriale)” (P. Sztomka).
Pensare al futuro oggi va in due direzioni principali:
- Il primo determina il pessimismo imperante, disegnando immagini cupe di degenerazione, distruzione e declino.
- La delusione nella razionalità scientifica e tecnica ha portato alla diffusione dell'irrazionalismo e del misticismo.
- L'intuizione, le emozioni e la sfera del subconscio si oppongono sempre più alla logica e alla ragione.
- I concetti postmodernisti radicali sostengono che la cultura moderna ha perso criteri affidabili per distinguere la realtà dal mito, la bellezza dalla bruttezza, il vizio dalla virtù. Sottolineano che siamo entrati in un’era di “massima libertà” – libertà dalla tradizione, dalla moralità, da P.
La seconda direzione è determinata dalla ricerca attiva di nuovi concetti di psicologia che possano fornire all'umanità linee guida positive per il futuro e liberarla da illusioni infondate.
I concetti postmodernisti di P. rifiutano innanzitutto la versione tradizionale della teoria dello sviluppo con il suo determinismo, fatalismo e finalismo. La maggior parte di loro ha scelto un altro approccio probabilistico allo sviluppo della società e della cultura. R. Nisbet, I. Wallerstein, A. Etzioni, M. Archer, W. Buckley nei loro concetti teorici interpretano P. come una possibile occasione di miglioramento, che con una certa probabilità può verificarsi, ma può anche passare inosservata.
Con tutta la varietà di approcci conosciuti nei paesi occidentali. sociologi, si basano tutti sul principio del “costruttivismo”, che è diventato il fondamento teorico del postmodernismo.
Il compito si riduce a trovare le forze trainanti dello sviluppo progressivo nelle normali attività quotidiane delle persone. Come osserva C. Lash, "La convinzione che i miglioramenti possano avvenire solo attraverso lo sforzo umano fornisce una soluzione a un puzzle altrimenti insolubile".
I concetti alternativi di P., sorti in linea con la teoria dell'attività, sono estremamente astratti, attraenti per "l'uomo in generale", con scarso interesse per le differenze di civiltà e culturali.
- Qui, in sostanza, c'è un nuovo tipo di utopia sociale: la costruzione cibernetica di culture sociali ideali, viste attraverso il prisma dell'attività umana.
Questi concetti ritornano all’umanità:
- linee guida positive,
- si chiama fede in un possibile sviluppo progressivo;
- sia pure a livello di alta teoria - le condizioni e le fonti dello sviluppo progressivo.
Non rispondono, tuttavia, alla domanda principale:
- perché una persona - “libera per” e “libera da” - a volte sceglie lo sviluppo progressivo e si batte per una “società attiva”,
- ma spesso, al contrario, si concentra sulla distruzione e sulla decadenza, che porta alla regressione o alla stagnazione.
Sulla base della teoria dell’attività è difficilmente possibile affermare che la creatività sia necessaria per la società, poiché non è possibile dimostrare se le persone in futuro vorranno realizzare la propria capacità di creare.
La risposta a queste domande non può essere trovata nella cibernetica e nella teoria dei sistemi, ma la cultura e la religione hanno sempre cercato di rispondere. Pertanto, un'alternativa al modernismo costruttivista nella teoria di P. può oggi diventare l'eticocentrismo socioculturale.
Il concetto etico-centrico di P. cominciò a prendere forma in russo. filosofia nel XIX secolo, sebbene le sue origini e i suoi prerequisiti risalgano a molto prima. Russo originale Filosofo la tradizione è sempre stata un'arena di lotta tra la ratio astratta dell'Europa occidentale e il Logos divino-umano concreto, cristiano orientale.
Rus. Il rinascimento religioso e filosofico della “Silver Age” ha cercato di comprendere i segreti irrazionali del cosmo con una mente concreta e vivente. In molti modi, ha preparato il terreno per la formazione di una civiltà russa etico-centrica alternativa all’Occidente. principi razionali della costruzione della vita.
Attualmente, dopo un intero secolo, i filosofi russi stanno tornando all’eredità dell’“Età dell’argento”, cercando di riascoltare i ritmi originari della cultura nazionale e di tradurli nel linguaggio rigoroso della scienza.
Studiare Filosofia:
- Russo il cosmismo, la filosofia dell'unità, l'organicismo filosofico-naturale possono far rivivere le tradizioni di una cultura nazionale originaria che vede la società non dal punto di vista della cibernetica tecnocentrica, ma dal punto di vista dell'integrità culturale.
La sintesi della civiltà russa è qualitativamente diversa da quella occidentale. in quanto richiede non la neutralizzazione delle dimensioni culturali e valoriali, ma, al contrario, la loro attivazione.
Secondo A.S. Panarin*, il modello biomorfico della cognizione rivela all'uomo l'immagine del cosmo vivente come un'integrità organica, il cui spazio risveglia in noi motivazioni di ordine superiore, incompatibili con l'egoismo consumistico irresponsabile.
*Alexander Sergeevich Panarin (26 dicembre 1940, Gorlovka, regione di Donetsk, SSR ucraino, URSS - 25 settembre 2003, Mosca) - Filosofo russo, critico del globalismo. Dottore in Filosofia, Professore dell'Università Statale di Mosca. MV Lomonosov.
Alexander Panarin ha scritto più di 250 lavori scientifici, tra cui 18 importanti monografie e libri. I più famosi, che hanno portato fama e popolarità a Panarin, sono "Scienza politica", "Previsione politica globale", "Civiltà ortodossa in un mondo globale", "Agenti del globalismo" (in seguito questo lavoro è stato incluso nella sua interezza nel libro “La tentazione del globalismo”, per il quale lo scienziato ha ricevuto il Premio Solzhenitsyn) e, infine, “Instabilità strategica nel 21° secolo”.
È nella natura vivente, considerandola non come officina, ma come tempio, che l'uomo trae energia creativa. Allo stesso tempo, il principio fondamentale dell’attività di trasformazione è l’avvertimento: “Non nuocere!”
Nelle scienze sociali moderne è necessaria una seria revisione dei principi, dei valori e delle priorità di base. Ella è in grado di suggerire nuove strade all'umanità se questa, a sua volta, trova la forza di utilizzarle."
Progresso e regressione della società - (dal latino progressus - movimento in avanti), una direzione di sviluppo, caratterizzata da una transizione dal inferiore al superiore, dal meno perfetto al più perfetto. Il concetto di progresso è opposto al concetto di regressione. La fede nel progresso è uno dei valori fondamentali della società industriale. Il progresso è direttamente correlato alla libertà e può essere considerato come la sua costante realizzazione storica. Il progresso può essere definito come uno sviluppo progressivo, in cui tutti i cambiamenti, soprattutto quelli qualitativi, seguono una linea ascendente, rivelata come una transizione dal inferiore al superiore, dal meno perfetto al più perfetto. Nell’orizzonte culturale e valoriale dell’umanità l’idea di progresso è apparsa relativamente tardi. L'antichità non lo sapeva. Nemmeno il Medioevo lo sapeva. La vera fede nel progresso cominciò ad affermarsi nella lotta contro la fede religiosa per l'emancipazione spirituale dell'uomo. Il trionfo dell'idea di progresso, degli umori e delle aspettative corrispondenti avvenne nel XVIII secolo, il secolo dell'illuminismo, della ragione, della fede nella grande missione liberatrice della scienza, della conoscenza oggettivamente vera. La fede nel progresso diventa qualcosa di scontato e, in profondità, convinzione interiore, disponibilità a servire, seguire e obbedire, anche simile alla fede in Dio. Viene assegnato un attributo al progresso
immutabilità storica.
Progresso e regressione sono opposti dialettici; lo sviluppo non può essere inteso solo come progresso o solo regressione. Nell'evoluzione degli organismi viventi e nello sviluppo della società, le tendenze progressive e regressive si combinano e interagiscono in modi complessi. Inoltre, la relazione tra queste tendenze nella materia vivente e nella società non si limita alle connessioni di alternanza o ciclicità (quando i processi di sviluppo sono pensati per analogia con la crescita, la fioritura e il successivo appassimento, invecchiamento degli organismi viventi). Essendo dialetticamente opposti, progresso e regresso della società sono inestricabilmente legati e compresi l'uno nell'altro. “...Ogni progresso nello sviluppo organico”, osservava Engels, “è allo stesso tempo un regresso, perché consolida lo sviluppo unilaterale ed esclude la possibilità di sviluppo in molte altre direzioni”.
Nel XX secolo i progressi furono compiuti in modo ambiguo. La Prima Guerra Mondiale assestò un colpo tangibile al progresso garantito. Lei ha mostrato
la futilità delle speranze in un miglioramento significativo della natura umana. Gli eventi successivi non hanno fatto altro che rafforzare questa tendenza alla delusione in atto. Nelle condizioni della società postindustriale si è giunti alla consapevolezza che il progresso in sé non è né automatico né garantito, ma che dobbiamo lottare per ottenerlo. E che il progresso è ambiguo e porta con sé conseguenze sociali negative. Quando applicato a un individuo, progresso significa fiducia nel successo, approvazione e incoraggiamento all'attività produttiva. Il successo e i risultati personali determinano lo status sociale di una persona e il suo progresso. Uno stile di vita orientato al successo è estremamente creativo e dinamico. Permette a una persona di essere ottimista, di non perdersi d'animo in caso di fallimento, di lottare per qualcosa di nuovo e di crearlo instancabilmente, di separarsi facilmente dal passato
ed essere aperti al futuro.
Tutti sanno che il progresso è un fenomeno positivo che denota il movimento verso un'organizzazione superiore. Ma la regressione è esattamente la direzione opposta: dal complesso al semplice, dall'alta organizzazione al basso degrado.
Consideriamo diversi punti di vista sulla storia della società dal punto di vista di questi due fenomeni multidirezionali.
- Il concetto di "età dell'oro". All'inizio ci fu una società di giustizia senza crisi e problemi, con completa comprensione reciproca, poi imboccò la via della regressione: iniziarono le controversie, iniziarono le guerre, cadde. Questa teoria riecheggia il racconto biblico sull'espulsione di Adamo e Eva dal paradiso.
- Sviluppo ciclico. Questo concetto è nato già nell'antichità. Dice che attraversa le stesse fasi a determinati intervalli, tutto si ripete.
- Sviluppo progressivo. Questa idea apparve anche nell'antichità, ma i filosofi francesi del XVIII secolo diedero un grande contributo a questa teoria.
Nella religione cristiana c'era lo sviluppo spirituale, l'elevazione a Dio. I criteri di regressione sono completamente opposti. Alcuni ricercatori considerano l’aumento e il miglioramento della qualità delle prestazioni come un progresso. Ma più tardi divenne chiaro che non si osservava un progresso in tutti gli ambiti della vita; in molti ambiti si poteva riscontrare una regressione. Ciò ha messo in discussione questo modello di sviluppo sociale.
Componenti del progresso
In generale, ci sono due componenti principali del progresso:

Possiamo concludere che la storia dello sviluppo della società non può procedere in modo lineare, rivelando alcuni schemi. O si eleva verso il progresso, per poi incontrare improvvisamente la regressione. Questa è una caratteristica che è in qualche modo una contraddizione nello sviluppo. A volte il suo prezzo è così alto che non ci accorgiamo quando iniziamo a scendere.
La natura sembra avere un certo equilibrio che non può essere disturbato. Se iniziamo a sviluppare un lato della vita, il benessere nell'altro inizia a diminuire a una velocità enorme. Si presuppone che questo equilibrio possa essere mantenuto se ci concentriamo sull'umanizzazione della società, cioè l'individualità di ogni persona sarà riconosciuta come il valore più alto.

Progresso e regressione biologica
Si tratta di una diminuzione del numero di individui di una determinata specie, di un deterioramento della diversità delle forme e di una diminuzione della protezione contro fattori esterni. Potrebbe causare la completa estinzione della specie
Il progresso in senso biologico è lo sviluppo di uno o più organismi per il loro miglior adattamento all'ambiente. Qui è possibile non solo complicare, ma anche semplificare l'organizzazione delle specie, l'importante è aumentare il livello di sopravvivenza nelle condizioni di un dato ambiente. Il biologo A.N. Severtsov ha sviluppato quattro caratteristiche principali del progresso biologico:
- miglioramento dell'ambiente;
- un aumento del numero dei rappresentanti del gruppo;
- varietà di forme;
- espansione della gamma.