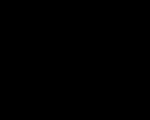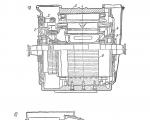Caratteristiche generali del gruppo IVA della tavola periodica. Elementi del gruppo IVA Caratteristiche generali degli elementi dei gruppi IIIA, IVA e VA
Il gruppo IVA racchiude gli elementi più importanti, senza i quali non esisteremmo né noi né la Terra sulla quale viviamo. Questo carbonio è la base di tutta la vita organica e il silicio è il “monarca” del regno minerale.
Se il carbonio e il silicio sono tipici non metalli, e lo stagno e il piombo sono metalli, il germanio occupa una posizione intermedia. Alcuni libri di testo lo classificano come non metallo, mentre altri lo classificano come metallo. È di colore bianco-argenteo e ha un aspetto metallico, ma ha un reticolo cristallino simile al diamante ed è un semiconduttore come il silicio.
Dal carbonio al piombo (con proprietà non metalliche decrescenti):
w diminuisce la stabilità dello stato di ossidazione negativo (-4)
w diminuisce la stabilità dello stato di ossidazione positivo più elevato (+4)
w aumenta la stabilità dello stato di ossidazione basso positivo (+2)
Il carbonio è il componente principale di tutti gli organismi. In natura esistono sia sostanze semplici formate da carbonio (diamante, grafite) che composti (anidride carbonica, carbonati vari, metano e altri idrocarburi nel gas naturale e nel petrolio). La frazione di massa del carbonio nei carboni duri raggiunge il 97%.
Un atomo di carbonio nello stato fondamentale può formare due legami covalenti mediante un meccanismo di scambio, ma in condizioni normali tali composti non si formano. Quando un atomo di carbonio entra in uno stato eccitato, utilizza tutti e quattro gli elettroni di valenza.
Il carbonio forma numerose modifiche allotropiche (vedi Fig. 16.2). Questi sono diamante, grafite, carabina e vari fullereni.
Nelle sostanze inorganiche lo stato di ossidazione del carbonio è +II e +IV. Con questi stati di ossidazione del carbonio, ci sono due ossidi.
Il monossido di carbonio (II) è un gas incolore, inodore e velenoso. Il nome banale è monossido di carbonio. Formato durante la combustione incompleta di carburante contenente carbonio. Per la struttura elettronica della sua molecola, vedere pagina 121. Secondo le proprietà chimiche, la CO è un ossido che non forma sali e quando riscaldato presenta proprietà riducenti (riduce in metallo molti ossidi di metalli poco attivi).
Il monossido di carbonio (IV) è un gas incolore e inodore. Il nome banale è anidride carbonica. Ossido acido. È leggermente solubile in acqua (fisicamente), reagisce parzialmente con essa, formando acido carbonico H2CO3 (le molecole di questa sostanza esistono solo in soluzioni acquose molto diluite).
L'acido carbonico è un acido dibasico molto debole che forma due serie di sali (carbonati e bicarbonati). La maggior parte dei carbonati sono insolubili in acqua. Degli idrocarbonati esistono come sostanze singole solo gli idrocarbonati di metalli alcalini e di ammonio. Sia lo ione carbonato che lo ione bicarbonato sono particelle di base, quindi sia i carbonati che i bicarbonati in soluzioni acquose subiscono idrolisi nell'anione.
Tra i carbonati, i più importanti sono il carbonato di sodio Na2CO3 (soda, carbonato di sodio, bicarbonato di sodio), il bicarbonato di sodio NaHCO3 (bicarbonato di sodio, bicarbonato di sodio), il carbonato di potassio K2CO3 (potassa) e il carbonato di calcio CaCO3 (gesso, marmo, calcare).
Reazione qualitativa alla presenza di anidride carbonica in una miscela di gas: la formazione di un precipitato di carbonato di calcio quando si fa passare il gas di prova attraverso acqua di calce (una soluzione satura di idrossido di calcio) e la successiva dissoluzione del precipitato quando si passa ulteriormente il gas. Reazioni in atto:
Ca2+2OH+CO2 = CaCO3+H2O;
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2 +2HCO3.
In farmacologia e medicina sono ampiamente utilizzati vari composti del carbonio: derivati dell'acido carbonico e degli acidi carbossilici, vari eterocicli, polimeri e altri composti. Pertanto, il carbolene (carbone attivo) viene utilizzato per assorbire ed eliminare varie tossine dal corpo; grafite (sotto forma di unguenti) - per il trattamento delle malattie della pelle; isotopi del carbonio radioattivo - per la ricerca scientifica (datazione al radiocarbonio).
Il carbonio è la base di tutte le sostanze organiche. Qualsiasi organismo vivente è costituito in gran parte da carbonio. Il carbonio è la base della vita. La fonte di carbonio per gli organismi viventi è solitamente la CO 2 proveniente dall'atmosfera o dall'acqua. Attraverso la fotosintesi, entra nelle catene alimentari biologiche in cui gli esseri viventi si mangiano l'un l'altro o i resti degli altri e ottengono così il carbonio per costruire i propri corpi. Il ciclo biologico del carbonio termina o con l'ossidazione e il ritorno nell'atmosfera, oppure con l'interramento sotto forma di carbone o petrolio.
Reazioni analitiche dello ione carbonato CO 3 2-
I carbonati sono sali dell'acido carbonico instabile e molto debole H 2 CO 3, che allo stato libero in soluzioni acquose è instabile e si decompone con il rilascio di CO 2: H 2 CO 3 - CO 2 + H 2 O
I carbonati di ammonio, sodio, rubidio e cesio sono solubili in acqua. Il carbonato di litio è leggermente solubile in acqua. I carbonati di altri metalli sono leggermente solubili in acqua. Gli idrocarbonati si dissolvono in acqua. Gli ioni carbonato nelle soluzioni acquose sono incolori e subiscono idrolisi. Le soluzioni acquose di bicarbonati di metalli alcalini non si colorano quando viene aggiunta loro una goccia di soluzione di fenolftaleina, il che consente di distinguere le soluzioni di carbonati dalle soluzioni di bicarbonati (test della farmacopea).
1.Reazione con cloruro di bario.
Ba 2+ + CO3 2 - -> BaCO 3 (bianco cristallino fine)
Precipitati carbonatici simili sono prodotti dai cationi calcio (CaCO 3) e stronzio (SrCO 3). Il precipitato si dissolve in acidi minerali e acido acetico. In una soluzione di H 2 SO 4 si forma un precipitato bianco di BaSO 4.
Al precipitato viene aggiunta lentamente, goccia a goccia, una soluzione di HC1 fino alla completa dissoluzione del precipitato: BaCO3 + 2 HC1 -> BaCl 2 + CO 2 + H 2 O
2. Reazione con solfato di magnesio (farmacopea).
Mg 2+ + COZ 2 - ->MgCO 3 (bianco)
L'idrocarbonato - ione HCO 3 - forma un precipitato MgCO 3 con solfato di magnesio solo durante l'ebollizione: Mg 2+ + 2 HCO3- -> MgCO 3 + CO 2 + H 2 O
Il precipitato di MgCO 3 si dissolve negli acidi.
3. Reazione con acidi minerali (farmacopea).
CO32- + 2H3O = H2CO3 + 2H2O
HCO3 - + H3O + = H2CO3 + 2H2O
H2CO3 -- CO2 + H2O
La CO 2 gassosa rilasciata viene rilevata dalla torbidità dell'acqua baritonale o di calce in un dispositivo per il rilevamento di gas, bolle di gas (CO 2) e nella provetta del ricevitore - torbidità della soluzione.
4.Reazione con uranile esacianoferrato (II).
2CO 3 2 - + (UO 2) 2 (marrone) -> 2 UO 2 CO 3 (incolore) + 4 -
Una soluzione marrone di uranile esacianoferrato (II) viene preparata mescolando una soluzione di acetato di uranile (CH 3 COO) 2 UO 2 con una soluzione di potassio esacianoferrato (II):
2(CH 3 SOO) 2 GO 2 + K 4 -> (UO 2) 2 + 4 CH 3 SOOK
Una soluzione di Na 2 CO 3 o K 2 CO 3 viene aggiunta goccia a goccia alla soluzione risultante agitando fino alla scomparsa del colore marrone.
5. Scoperta separata di ioni carbonato e ioni bicarbonato mediante reazioni con cationi calcio e ammoniaca.
Se nella soluzione sono presenti contemporaneamente ioni carbonato e bicarbonato, ciascuno di essi può essere aperto separatamente.
Per fare ciò, aggiungere prima un eccesso di soluzione CaCl 2 alla soluzione analizzata. In questo caso la CO3 2 viene precipitata sotto forma di CaCO 3:
CO32- + Ca2+ = CaCO3
Gli ioni bicarbonato rimangono in soluzione, poiché le soluzioni di Ca(HCO 3) 2 sono in acqua. Si separa il precipitato dalla soluzione e a quest'ultima si aggiunge una soluzione di ammoniaca. HCO 2 - anioni con ammoniaca e cationi calcio danno nuovamente un precipitato di CaCO 3: HCO 3 - + Ca 2+ + NH 3 -> CaCO3 + NH 4 +
6. Altre reazioni dello ione carbonato.
Gli ioni carbonato, quando reagiscono con il cloruro di ferro (III) FeCl 3, formano un precipitato marrone Fe(OH)CO 3, con nitrato d'argento - un precipitato bianco di carbonato d'argento Ag 2 CO3, solubile in HbTO3 e si decompone quando bolle in acqua fino a precipitato scuro Ag 2 O ISO 2: Ag 2 CO 3 -> Ag 2 O + CO 2
Reazioni analitiche dello ione acetato CH 3 COO"
Acetato - ione CH 3 COO- - anione dell'acido acetico monobasico debole CH 3 COOH: incolore in soluzioni acquose, sottoposto a idrolisi, non ha proprietà redox; È un ligando abbastanza efficace e forma complessi stabili di acetato con cationi di molti metalli. Quando reagisce con gli alcoli in un ambiente acido, produce esteri.
Gli acetati di ammonio, alcali e la maggior parte degli altri metalli sono altamente solubili in acqua. Gli acetati di argento CH 3 COOAg e di mercurio (I) sono meno solubili in acqua rispetto agli acetati di altri metalli.
1. Reazione con cloruro di ferro (III) (farmacopea).
A pH = 5-8, lo ione acetato con i cationi Fe (III) forma acetato solubile rosso scuro (il colore del tè forte) o ossiacetato di ferro (III).
In soluzione acquosa è parzialmente idrolizzato; l'acidificazione della soluzione con acidi minerali sopprime l'idrolisi e porta alla scomparsa del colore rosso della soluzione.
3 CH3COOH + Fe --> (CH 3 COO) 3 Fe + 3 H +
Durante l'ebollizione, dalla soluzione precipita un precipitato rosso-marrone di acetato basico di ferro (III):
(CH 3 COO) 3 Fe + 2 H 2 O<- Fe(OH) 2 CH 3 COO + 2 СН 3 СООН
A seconda del rapporto tra le concentrazioni di ferro (III) e ioni acetato, la composizione del sedimento può cambiare e corrispondere, ad esempio, alle formule: Fe OH (CH 3 COO) 2, Fe 3 (OH) 2 O 3 (CH 3 COO), Fe 3 O (OH)(CH 3 COO) 6 o Fe 3 (OH) 2 (CH 3 COO) 7.
La reazione è ostacolata dagli anioni CO 3 2 -, SO 3 "-, PO 4 3 -, 4, che formano precipitazione con ferro (III), così come dagli anioni SCN- (che danno complessi rossi con cationi Fe 3+) , ioduro - ione G, si ossida a iodio 1 2, conferendo alla soluzione un colore giallo.
2. Reazione con acido solforico.
Lo ione acetato in un ambiente fortemente acido si trasforma in acido acetico debole, i cui vapori hanno un caratteristico odore di aceto:
CH3COO-+H+<- СН 3 СООН
La reazione è ostacolata dagli anioni NO 2 \ S 2 -, SO 3 2 -, S 2 O 3 2 -, che rilasciano anche prodotti gassosi con odore caratteristico in un ambiente concentrato di H 2 SO4.
3. Reazione di formazione di etere etilico acetico (farmacopea).
La reazione viene condotta in un ambiente di acido solforico. Con etanolo:
CH 3 COO- + H + -- CH 3 COOH CH 3 COOH + C 2 H 5 OH = CH 3 COOC 2 H 4 + H 2 O
L'acetato di etile rilasciato si riconosce dal suo caratteristico odore gradevole. I sali d'argento catalizzano questa reazione, quindi si consiglia di aggiungere una piccola quantità di AgNO 3 durante l'esecuzione di questa reazione.
Allo stesso modo, reagendo con l'alcol amilico C 5 HcOH, si forma anche l'acetato di amile CH 3 SOOC 5 Ni (-pera-), che ha un odore gradevole. Si avverte l'odore caratteristico dell'acetato di etile, che si intensifica quando la miscela viene leggermente riscaldata .
Reazioni analitiche del tartrato - ione POC - CH(OH) - CH(OH) - CONST. Lo ione tartrato è un anione dell'acido tartarico dibasico debole:
HO-CH-COOH
HO-CH-COOH
Lo ione tartrato è altamente solubile in acqua. Nelle soluzioni acquose, gli ioni tartrato sono incolori, subiscono idrolisi e sono soggetti a formazione di complessi, dando complessi tartrato stabili con cationi di molti metalli. L'acido tartarico forma due serie di sali: tartrati medi contenenti un tartrato a doppia carica - lo ione COCH(OH)CH(OH)COO - e tartrati acidi - idrotartrati contenenti un tartrato di idrogeno a carica singola - HOOOCH(OH)CH(OH) COO - ione. Il tartrato idrogeno di potassio (-tartaro-) KNS 4 H 4 O 6 è praticamente insolubile in acqua, che viene utilizzata per aprire i cationi potassio. Anche il sale di calcio medio è leggermente solubile in acqua. Il sale di potassio medio K 2 C 4 H 4 O 6 è altamente solubile in acqua.
I. Reazione con cloruro di potassio (farmacopea).
C 4 H 4 O 6 2 - + K + + N + -> KNS 4 H 4 O 6 1 (bianco)
2. Reazione con resorcinolo in ambiente acido (farmacopea).
I tartrati, quando riscaldati con resorcinolo meta - C 6 H 4 (OH) 2 in acido solforico concentrato, formano prodotti di reazione rosso ciliegia.
14) Reazioni con il complesso ammoniacale dell'argento. Cade un precipitato nero di argento metallico.
15) Reazione con solfato di ferro (II) e perossido di idrogeno.
Aggiunta di una soluzione acquosa diluita di FeSO 4 e H 2 O 2 ad una soluzione contenente tartrati. porta alla formazione di un complesso di ferro instabile dal colore rugoso. Il successivo trattamento con soluzione alcalina NaOH porta al colore blu del complesso.
Reazioni analitiche dello ione ossalato C 2 O 4 2-
Lo ione ossalato C 2 O 4 2- è un anione dell'acido ossalico dibasico H 2 C 2 O 4 di media forza, relativamente ben solubile in acqua. Lo ione ossalato nelle soluzioni acquose è incolore, parzialmente idrolizzato, un forte agente riducente, un ligando efficace - forma complessi ossalato stabili con cationi di molti metalli. Gli ossalati di metalli alcalini, magnesio e ammonio sono solubili in acqua, mentre altri metalli sono leggermente solubili in acqua.
1Reazione con cloruro di bario Ba 2+ + C 2 O 4 2- = BaC 2 O 4 (bianco) Il precipitato si scioglie in acidi minerali e in acido acetico (all'ebollizione). 2. Reazione con cloruro di calcio (farmacopea): Ca 2+ + C 2 O 4 2 - = CaC 2 O 4 (bianco)
Il precipitato è solubile negli acidi minerali, ma insolubile nell'acido acetico.
3. Reazione con nitrato d'argento.
2 Ag + + C 2 O 4 2 - -> Ag2C2O 4 .|.(cagliato) Test di solubilità. Il sedimento è diviso in 3 parti:
UN). Nella prima provetta con il precipitato aggiungere goccia a goccia, agitando, fino allo scioglimento del precipitato;
B). Aggiungere goccia a goccia, agitando, una soluzione concentrata di ammoniaca nella seconda provetta con il precipitato finché il precipitato non si scioglie; V). Nella terza provetta contenente il sedimento aggiungere 4-5 gocce della soluzione HC1; Nella provetta rimane un precipitato bianco di cloruro d'argento:
Ag 2 C 2 O 4 + 2 HC1 -> 2 AC1 (bianco) + H 2 C 2 O 4
4.Reazione con permanganato di potassio. Gli ioni ossalato con KMnO 4 in un ambiente acido vengono ossidati con rilascio di CO 2; la soluzione di KMpO 4 cambia colore a causa della riduzione del manganese (VII) a manganese (II):
5 C 2 O 4 2 - + 2 MnO 4 " + 16 H + -> 10 CO 2 + 2 Mn 2+ + 8 H 2 O
Soluzione diluita di KMnO 4. Quest'ultimo si scolorisce; si osserva il rilascio di bolle di gas - CO 2 -.
38 Elementi del gruppo VA
Caratteristiche generali del gruppo VA della tavola periodica. nella forma s x p y la configurazione elettronica del livello di energia esterna degli elementi del gruppo VA.
L'arsenico e l'antimonio hanno diverse modifiche allotropiche: sia con un reticolo cristallino molecolare che metallico. Tuttavia, sulla base di un confronto tra la stabilità delle forme cationiche (As 3+, Sb 3+), l'arsenico è classificato come non metallo e l'antimonio come metallo.
stati di ossidazione stabili per gli elementi del gruppo VA
Dall'azoto al bismuto (con diminuzione delle proprietà non metalliche):
w la stabilità dello stato di ossidazione negativo (-3) diminuisce (m. proprietà dei composti dell'idrogeno)
w diminuisce la stabilità dello stato di ossidazione positivo più elevato (+5)
w aumenta la stabilità dello stato di ossidazione basso positivo (+3)
Sapere
- posizione del carbonio e del silicio nella tavola periodica, presenza in natura e applicazione pratica;
- struttura atomica, valenza, stati di ossidazione del carbonio e del silicio;
- metodi di produzione e proprietà di sostanze semplici: grafite, diamante e silicio; nuove forme allotropiche del carbonio;
- principali tipologie di composti del carbonio e del silicio;
- caratteristiche degli elementi del sottogruppo del germanio;
essere in grado di
- elaborare equazioni di reazione per la produzione di sostanze semplici carbonio e silicio e reazioni che caratterizzano le proprietà chimiche di queste sostanze;
- confrontare le proprietà degli elementi nel gruppo del carbonio;
- caratterizzare composti praticamente importanti di carbonio e silicio;
- eseguire calcoli utilizzando equazioni di reazione in cui sono coinvolti carbonio e silicio;
Proprio
Capacità di prevedere il corso delle reazioni che coinvolgono il carbonio, il silicio e i loro composti.
La struttura degli atomi. Prevalenza in natura
Il gruppo IVA della tavola periodica è composto da cinque elementi con numeri atomici pari: carbonio C, silicio Si, germanio Ge, stagno Sn e piombo Pb (Tabella 21.1). In natura tutti gli elementi del gruppo sono miscele di isotopi stabili. Il carbonio ha due isogoni: *|C (98,9%) e *§C (1,1%). Inoltre in natura sono presenti tracce dell'isotopo radioattivo "|С с t t= 5730 anni. Si forma costantemente durante le collisioni di neutroni provenienti dalla radiazione cosmica con nuclei di azoto nell'atmosfera terrestre:
Tabella 21.1
Caratteristiche degli elementi del gruppo IVA
*Elemento biogenico.
L'isotopo principale del carbonio è di particolare importanza in chimica e fisica, poiché si basa sull'unità di massa atomica, vale a dire { /2 parte della massa di un atomo 'ICO Sì).
Il silicio ha tre isotopi in natura; Tra questi, il più comune è ^)Si (92,23%). Il germanio ha cinque isotopi (j^Ge - 36,5%). Stagno - 10 isotopi. Questo è un record tra gli elementi chimici. Il più comune è 12,5 gSn (32,59%). Il piombo ha quattro isotopi: 2 §^Pb (1,4%), 2 §|Pb (24,1%), 2 82?b (22,1%) e 2 82?b (52,4%). Gli ultimi tre isotopi del piombo sono i prodotti finali del decadimento degli isotopi radioattivi naturali dell'uranio e del torio, e quindi il loro contenuto nella crosta terrestre è aumentato durante l'esistenza della Terra.
In termini di abbondanza nella crosta terrestre, il carbonio è uno dei primi dieci elementi chimici. Si trova sotto forma di grafite, molte varietà di carbone, come parte di petrolio, gas combustibile naturale, formazioni calcaree (CaCO e), dolomite (CaC0 3 -MgC0 3) e altri carbonati. Il diamante naturale, sebbene costituisca una parte insignificante del carbonio disponibile, è estremamente prezioso come minerale bello e duro. Ma, naturalmente, il valore più alto del carbonio risiede nel fatto che è la base strutturale delle sostanze bioorganiche che formano i corpi di tutti gli organismi viventi. Il carbonio è giustamente considerato il primo tra molti elementi chimici necessari per l'esistenza della vita.
Il silicio è il secondo elemento più abbondante nella crosta terrestre. La sabbia, l'argilla e molte rocce che vedi sono costituite da minerali di silicio. Ad eccezione delle varietà cristalline di ossido di silicio, tutti i suoi composti naturali lo sono silicati, cioè. sali di vari acidi silicici. Questi acidi stessi non sono stati ottenuti come sostanze individuali. Gli ortosilicati contengono ioni SiOj~, i metasilicati sono costituiti da catene polimeriche (Si0 3 ") w. La maggior parte dei silicati sono costruiti su una struttura di atomi di silicio e ossigeno, tra i quali possono essere posizionati atomi di qualsiasi metallo e alcuni non metalli (fluoro). Bene. I minerali di silicio conosciuti includono quarzo Si0 2, feldspati (ortoclasio KAlSi 3 0 8), miche (muscovite KAl 3 H 2 Si 3 0 12). In totale, si conoscono più di 400 minerali di silicio. Più della metà dei gioielli e degli ornamenti le pietre sono composti di silicio. La struttura ossigeno-silicio causa minerali di silicio a bassa solubilità nell'acqua. Solo da sorgenti calde sotterranee nel corso di migliaia di anni si possono depositare escrescenze e croste di composti di silicio. Rocce di questo tipo includono il diaspro.
Non è necessario parlare dell'epoca della scoperta del carbonio, del silicio, dello stagno e del piombo, poiché sono conosciuti fin dall'antichità sotto forma di sostanze o composti semplici. Il germanio fu scoperto da K. Winkler (Germania) nel 1886 nel raro minerale argirodito. Divenne presto chiaro che l'esistenza di un elemento con tali proprietà era stata prevista da D.I. Mendeleev. Il nome del nuovo elemento ha causato polemiche. Mendeleev, in una lettera a Winkler, sostenne fortemente il nome germanio.
Gli elementi del gruppo IVA hanno quattro elettroni di valenza nella parte più esterna S- e sottolivelli p:

Formule elettroniche degli atomi:

Nello stato fondamentale questi elementi sono bivalenti e nello stato eccitato diventano tetravalenti:

Il carbonio e il silicio formano pochissimi composti chimici allo stato bivalente; in quasi tutti i composti stabili sono tetravalenti. Più in basso nel gruppo, la stabilità dello stato bivalente aumenta per germanio, stagno e piombo e diminuisce la stabilità dello stato tetravalente. Pertanto, i composti di piombo (1U) si comportano come forti agenti ossidanti. Questo modello è evidente anche nel gruppo VA. Una differenza importante tra il carbonio e gli altri elementi del gruppo è la capacità di formare legami chimici in tre diversi stati di ibridazione: sp, sp 2 E sp3. Al silicio è rimasto praticamente un solo stato ibrido sp3. Ciò è chiaramente evidente quando si confrontano le proprietà dei composti del carbonio e del silicio. Ad esempio, il monossido di carbonio C0 2 è un gas (anidride carbonica) e l'ossido di silicio Si0 2 è una sostanza refrattaria (quarzo). La prima sostanza è gassosa perché quando sp-ibridazione del carbonio, tutti i legami covalenti sono chiusi nella molecola di C0 2:
L'attrazione tra le molecole è debole e questo determina lo stato della sostanza. Nell'ossido di silicio, quattro orbitali ibridi 5p 3 di silicio non possono essere chiusi su due atomi di ossigeno. Un atomo di silicio si lega a quattro atomi di ossigeno, ciascuno dei quali a sua volta si lega a un altro atomo di silicio. Il risultato è una struttura a telaio con la stessa forza di legami tra tutti gli atomi (vedi diagramma, vol. 1, p. 40).
I composti di carbonio e silicio con la stessa ibridazione, ad esempio metano CH 4 e silano SiH 4, sono simili nella struttura e nelle proprietà fisiche. Entrambe le sostanze sono gas.
L'elettronegatività degli elementi IVA è ridotta rispetto agli elementi del gruppo VA, e ciò è particolarmente evidente negli elementi del 2o e 3o periodo. La metallicità degli elementi nel gruppo IVA è più pronunciata che nel gruppo VA. Il carbonio, sotto forma di grafite, è un conduttore. Il silicio e il germanio sono semiconduttori, mentre lo stagno e il piombo sono veri metalli.
16.1. Caratteristiche generali degli elementi dei gruppi IIIA, IVA e VA
B |
C |
N |
Alluminio |
Sì |
P |
Ga |
Ge Germanio |
COME |
In |
Sn |
Sb |
Tl |
Pb |
Bi |
La composizione di questi tre gruppi del sistema naturale di elementi è mostrata nella Figura 16.1. Qui vengono forniti anche i valori dei raggi orbitali degli atomi (in angstrom). È in questi gruppi che il confine tra elementi che formano metalli (raggio orbitale maggiore di 1,1 angstrom) ed elementi che formano non metalli (raggio orbitale inferiore a 1,1 angstrom) è più chiaramente visibile. Nella figura questo confine è rappresentato da una doppia linea. Non dimentichiamo che questo confine è ancora arbitrario: alluminio, gallio, stagno, piombo e antimonio sono certamente metalli anfoteri, ma anche boro, germanio e arsenico mostrano qualche segno di anfotericità.
Degli atomi degli elementi di questi tre gruppi, i seguenti si trovano più spesso nella crosta terrestre: Si (w = 25,8%), Al (w = 7,57%), P (w = 0,090%), C (w = 0,087%) e N (w = 0,030%). Questi sono quelli che incontrerai in questo capitolo.
Formule elettroniche di valenza generale degli atomi degli elementi del gruppo IIIA - ns 2 n.p. 1, gruppo IVA – ns 2 n.p. 2, gruppi VA – ns 2 n.p. 3. Gli stati di ossidazione più elevati sono pari al numero del gruppo. Quelli intermedi sono 2 in meno.
Tutte le sostanze semplici formate dagli atomi di questi elementi (ad eccezione dell'azoto) sono solide. Molti elementi sono caratterizzati da allotropia (B, C, Sn, P, As). Esistono solo tre sostanze molecolari stabili: azoto N2, fosforo bianco P4 e arsenico giallo As4.
Gli elementi non metallici di questi tre gruppi tendono a formare composti di idrogeno molecolare con legami covalenti. Inoltre, il carbonio ne ha così tanti che gli idrocarburi e i loro derivati sono studiati da una scienza separata: la chimica organica. Il secondo maggior numero di composti dell'idrogeno tra questi elementi è il boro. I boroidruri (borani) sono molto numerosi e di struttura complessa, quindi anche la chimica dei boroidruri è diventata un ramo separato della chimica. Il silicio forma solo 8 composti di idrogeno (silani), azoto e fosforo - due ciascuno, il resto - un composto di idrogeno ciascuno. Formule molecolari dei composti dell'idrogeno più semplici e loro nomi:
La composizione degli ossidi superiori corrisponde allo stato di ossidazione più elevato pari al numero del gruppo. Il tipo di ossidi superiori in ciascun gruppo cambia gradualmente con l'aumentare del numero atomico da acido ad anfotero o basico.
Il carattere acido-base degli idrossidi è molto vario. Quindi, HNO 3 è un acido forte e TlOH è un alcali.
1.Creare formule elettroniche abbreviate e diagrammi energetici degli atomi degli elementi dei gruppi IIIA, IVA e VA. Indicare gli elettroni esterni e di valenza.
L'atomo di azoto ha tre elettroni spaiati, quindi mediante il meccanismo di scambio può formare tre legami covalenti. Può formare un altro legame covalente mediante il meccanismo donatore-accettore, in cui l'atomo di azoto acquisisce una carica formale positiva di +1 e. Pertanto, l’azoto massimo è pentavalente, ma la sua covalenza massima è quattro (questo spiega l’affermazione spesso incontrata secondo cui l’azoto non può essere pentavalente).
Quasi tutto l'azoto terrestre si trova nell'atmosfera del nostro pianeta. Una quota significativamente minore di azoto è presente nella litosfera sotto forma di nitrati. L'azoto fa parte dei composti organici contenuti in tutti gli organismi e nei prodotti della loro decomposizione.
L'azoto costituisce l'unico semplice molecolare sostanza N 2 con un triplo legame biatomico nella molecola (Fig. 16.2). L'energia di questo legame è 945 kJ/mol, che supera i valori di altre energie di legame (vedi Tabella 21). Questo spiega l'inerzia dell'azoto a temperature ordinarie. Secondo le sue caratteristiche fisiche, l'azoto è un gas incolore e inodore, a noi familiare fin dalla nascita (tre quarti dell'atmosfera terrestre sono costituiti da azoto). L'azoto è leggermente solubile in acqua.

L'azoto ne forma due composti dell'idrogeno: ammoniaca NH 3 e idrazina N 2 H 6:

L'ammoniaca è un gas incolore dall'odore pungente e soffocante. L'inalazione imprudente di vapori di ammoniaca concentrati può causare spasmi e soffocamento. L'ammoniaca è molto solubile in acqua, il che si spiega con la formazione di quattro legami idrogeno con le molecole d'acqua da parte di ciascuna molecola di ammoniaca.

La molecola di ammoniaca è una particella base (vedi Appendice 14). Accettando un protone, si trasforma in uno ione ammonio. La reazione può avvenire sia in soluzione acquosa che in fase gassosa:
NH 3 + H 2 O NH 4 + OH (in soluzione);
NH 3 + H 3 O B = NH 4 + H 2 O (in soluzione);
NH 3g + HCl g = NH 4 Cl cr (in fase gassosa).
Le soluzioni acquose di ammoniaca sono sufficientemente alcaline da far precipitare idrossidi insolubili, ma non abbastanza alcaline da consentire agli idrossidi anfoteri di dissolversi in esse per formare complessi idrossilici. Pertanto, la soluzione di ammoniaca è conveniente da utilizzare per la preparazione di idrossidi anfoteri P-elementi: Al(OH) 3, Be(OH) 2, Pb(OH) 2, ecc., ad esempio:
Pb2 + 2NH3 + 2H2O = Pb(OH)2 + 2NH4.
Quando viene accesa nell'aria, l'ammoniaca brucia formando azoto e acqua; quando interagisce con l'ossigeno in presenza di un catalizzatore (Pt), viene ossidato reversibilmente a monossido di azoto:
4NH 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O (senza catalizzatore),
4NH 3 + 5O 2 4NO + 6H 2 O (con catalizzatore).
Se riscaldata, l'ammoniaca può ridurre gli ossidi di metalli poco attivi, ad esempio il rame:
3CuO + 2NH3 = 3Cu + N2 + 3H2O
I sali di ammonio nelle loro proprietà (ad eccezione della stabilità termica) sono simili ai sali di metalli alcalini. come questi ultimi, quasi tutti sono solubili in acqua, ma, poiché lo ione ammonio è un acido debole, vengono idrolizzati a livello del catione. Quando riscaldati, i sali di ammonio si decompongono:
NH4CI = NH3 + HCl;
(NH4)2SO4 = NH4HSO4 + NH3;
(NH4) 2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O;
NH4HS = NH3 + H2S;
NH4NO3 = N2O + 2H2O;
NH4NO2 = N2 + 2H2O;
(NH4)2HPO4 = NH3 + (NH4)H2PO4;
(NH4)H2PO4 = NH4PO3 + H2O.
L'azoto nei vari stati di ossidazione ne forma cinque ossidi: N2O, NO, N2O3, NO2 e N2O5.
Il più stabile di questi è il biossido di azoto. È un gas velenoso marrone con un odore sgradevole. Reagisce con l'acqua:
2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3.
Con una soluzione alcalina la reazione avviene con la formazione di nitrato e nitrito.
N 2 O e NO sono ossidi che non formano sali.
N 2 O 3 e N 2 O 5 sono ossidi acidi. Reagendo con l'acqua, formano rispettivamente soluzioni di acido nitroso e nitrico.
L'ossoacido di azoto nello stato di ossidazione +III è l'acido nitroso HNO 2. È un acido debole le cui molecole esistono solo in soluzione acquosa. I suoi sali sono nitriti. L'azoto nell'acido nitroso e nei nitriti viene facilmente ossidato allo stato di ossidazione +V.
A differenza dell'acido nitroso, l'acido nitrico HNO 3 è un acido forte. La struttura della sua molecola può essere espressa in due modi:
L'acido nitrico si miscela a tutti gli effetti con l'acqua, reagendo completamente con essa in soluzioni diluite:
HNO3 + H2O = H3O + NO3
L'acido nitrico e le sue soluzioni sono forti agenti ossidanti. Quando l'acido nitrico viene diluito, la sua attività ossidativa diminuisce. Nelle soluzioni di acido nitrico di qualsiasi concentrazione, gli atomi ossidanti sono principalmente atomi di azoto, non idrogeno. Pertanto, durante l'ossidazione di varie sostanze con acido nitrico, l'idrogeno viene rilasciato solo come sottoprodotto. A seconda della concentrazione dell'acido e dell'attività riducente dell'altro reagente, i prodotti della reazione possono essere NO 2, NO, N 2 O, N 2 e anche NH 4. Molto spesso si forma una miscela di gas, ma nel caso dell'acido nitrico concentrato viene rilasciato solo biossido di azoto:
Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
3FeS + 30HNO3 = Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 27NO2 + 15H2O
Nel caso dell'acido nitrico diluito, molto spesso viene rilasciato monossido di azoto:
Fe + 4HNO 3 = Fe(NO 3) 3 + NO + 2H 2 O
3H2S + 2HNO3 = 2NO + 4H2O + 3S
Nel caso di acido nitrico molto diluito che reagisce con un forte agente riducente (Mg, Al, Zn), si formano ioni ammonio:
4Mg + 10HNO3 = 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
Quei metalli che sono passivati dall'acido solforico concentrato sono anche passivati dall'acido nitrico concentrato.
I sali dell'acido nitrico - i nitrati - sono composti termicamente instabili. Quando riscaldati si decompongono:
2KNO3 = 2KNO2 + O2 ;
2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2 + O2;
2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2.
1. Scrivi equazioni descrittive per le reazioni fornite nel testo del paragrafo.
2. Creare equazioni di reazione che caratterizzano le proprietà chimiche di a) ammoniaca, b) acido nitrico, c) nitrato di zinco.
Proprietà chimiche dell'ammoniaca e dell'acido nitrico.
16.3. Fosforo
A differenza dell’atomo di azoto, atomo il fosforo può formare cinque legami covalenti mediante un meccanismo di scambio. La spiegazione tradizionale di ciò si riduce alla possibilità di eccitazione di uno dei 3 S-elettroni e la sua transizione a 3 D-sottolivello.
L'elemento fosforo si forma parecchio modifiche allotropiche. Di queste, tre modifiche sono le più stabili: fosforo bianco, fosforo rosso e fosforo nero. Il fosforo bianco è una sostanza cerosa e tossica incline alla combustione spontanea nell'aria, costituita da molecole P4. Il fosforo rosso è una sostanza non molecolare, meno attiva, di colore rosso scuro con una struttura piuttosto complessa. In genere, il fosforo rosso contiene sempre una miscela di bianco, quindi sia il fosforo bianco che quello rosso vengono sempre immagazzinati sotto uno strato d'acqua. Anche il fosforo nero è una sostanza non molecolare con una struttura quadro complessa.
Le molecole di fosforo bianco sono tetraedriche, l'atomo di fosforo in esse contenuto è trivalente. Modello ball-and-stick e formula strutturale della molecola di fosforo bianco:
![]()
La struttura del fosforo rosso può essere espressa dalla formula strutturale:

Il fosforo si ottiene dal fosfato di calcio mediante riscaldamento con sabbia e coke:
Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C = 3CaSiO3 + 2P + 5CO.
Il fosforo è maggiormente caratterizzato da composti con lo stato di ossidazione +V. Quando reagisce con il cloro in eccesso, il fosforo forma pentacloruro. Durante la combustione di qualsiasi modifica allotropica del fosforo si forma ossigeno in eccesso ossido fosforo(V):
4P + 5O2 = 2P2O5.
Esistono due modifiche dell'ossido di fosforo (V): non molecolare (con la formula più semplice P 2 O 5) e molecolare (con la formula molecolare P 4 O 10). L'ossido di fosforo è solitamente una miscela di queste sostanze.

Questo ossido acido molto igroscopico, reagendo con l'acqua, forma successivamente acidi metafosforici, difosforici e ortofosforici:
P 2 O 5 + H 2 O = 2HPO 3, 2HPO 3 + H 2 O = H 4 P 2 O 7, H 4 P 2 O 7 + H 2 O = 2H 3 PO 4.
Ortofosforico acido(solitamente chiamato semplicemente fosforico) è un acido debole tribasico (vedi Appendice 13). È una sostanza cristallina incolore, molto solubile in acqua. Quando reagisce con basi forti, a seconda del rapporto dei reagenti, forma tre file sali(ortofosfati, idroortofosfati e diidrogeno ortofosfati - solitamente il prefisso “ortho” viene omesso dai loro nomi):
H3PO4 + OH = H2PO4 + H2O,
H3PO4 + 2OH = HPO42 + 2H2O,
H3PO4 + 3OH = PO43 + 3H2O.
La maggior parte dei fosfati medi (ad eccezione dei sali di elementi alcalini diversi dal litio) sono insolubili in acqua. Ci sono significativamente più fosfati acidi solubili.
L'acido fosforico si ottiene dal fosfato di calcio naturale trattandolo con acido solforico in eccesso. Con un diverso rapporto tra fosfato di calcio e acido solforico si forma una miscela di fosfato monobasico e solfato di calcio, utilizzata in agricoltura come fertilizzante minerale denominata “superfosfato semplice”:
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 2H3PO4 + 3CaSO4 ;
Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4.
Dalla reazione si ottiene il più pregiato "doppio perfosfato".
Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 = 3Ca(H2PO4) 3.
La sostanza principale di questo fertilizzante minerale è il fosfato monobasico di calcio.
1. Comporre equazioni molecolari per reazioni per le quali le equazioni ioniche sono fornite nel testo del paragrafo.
2. Annotare in modo descrittivo le equazioni per le reazioni fornite nel testo del paragrafo.
3. Creare equazioni di reazione che caratterizzano le proprietà chimiche di a) fosforo, b) ossido di fosforo (V), c) acido ortofosforico, d) sodio diidrogeno fosfato.
Proprietà chimiche dell'acido fosforico.
16.4. Carbonio
Il carbonio è il componente principale di tutti gli organismi. In natura esistono sia sostanze semplici formate da carbonio (diamante, grafite) che composti (anidride carbonica, carbonati vari, metano e altri idrocarburi nel gas naturale e nel petrolio). La frazione di massa del carbonio nei carboni duri raggiunge il 97%.
Atomo il carbonio nello stato fondamentale può formare due legami covalenti mediante un meccanismo di scambio, ma in condizioni normali tali composti non si formano. Quando un atomo di carbonio entra in uno stato eccitato, utilizza tutti e quattro gli elettroni di valenza.
Il carbonio si forma parecchio modifiche allotropiche(vedi Fig. 16.2). Questi sono diamante, grafite, carabina e vari fullereni.

Il diamante è una sostanza cristallina molto dura, incolore e trasparente. I cristalli di diamante sono costituiti da atomi di carbonio sp Stato 3-ibridato, che forma una struttura spaziale.
La grafite è una sostanza cristallina piuttosto morbida di colore grigio-nero. I cristalli di grafite sono costituiti da strati piatti in cui si trovano gli atomi di carbonio sp Stato 2-ibrido e forma reti con celle esagonali.
La carbina è una sostanza incolore con struttura fibrosa, costituita da molecole lineari in cui gli atomi di carbonio si trovano in sp-stato ibrido (=C=C=C=C= o –C C–C C–).
I fullereni sono modifiche allotropiche molecolari del carbonio con molecole C 60, C 80, ecc. Le molecole di queste sostanze sono sfere a maglia cava.
Tutte le modifiche del carbonio mostrano proprietà riducenti in misura maggiore rispetto a quelle ossidanti, ad esempio il coke (un prodotto della lavorazione del carbone; contiene fino al 98% di carbonio) viene utilizzato per ridurre il ferro dai minerali di ossido e una serie di altri metalli dai loro ossidi :
Fe 2 O 3 + 3C = 2Fe + 3CO (ad alta temperatura).
La maggior parte dei composti del carbonio vengono studiati in chimica organica, che imparerai nelle classi 10 e 11.
Nelle sostanze inorganiche lo stato di ossidazione del carbonio è +II e +IV. Con questi stati di ossidazione del carbonio, ce ne sono due ossido.
Il monossido di carbonio (II) è un gas incolore, inodore e velenoso. Il nome banale è monossido di carbonio. Formato durante la combustione incompleta di carburante contenente carbonio. Per la struttura elettronica della sua molecola, vedere pagina 121. Secondo le proprietà chimiche, la CO è un ossido che non forma sali e quando riscaldato presenta proprietà riducenti (riduce in metallo molti ossidi di metalli poco attivi).
Il monossido di carbonio (IV) è un gas incolore e inodore. Il nome banale è anidride carbonica. Ossido acido. È leggermente solubile in acqua (fisicamente), reagisce parzialmente con essa formando carbone acido H 2 CO 3 (le molecole di questa sostanza esistono solo in soluzioni acquose molto diluite).
L'acido carbonico è un acido molto debole (vedi Appendice 13), dibasico, forma due file sali(carbonati e bicarbonati). La maggior parte dei carbonati sono insolubili in acqua. Degli idrocarbonati esistono come sostanze singole solo gli idrocarbonati di metalli alcalini e di ammonio. Sia lo ione carbonato che lo ione bicarbonato sono particelle di base, quindi sia i carbonati che i bicarbonati in soluzioni acquose subiscono idrolisi nell'anione.
Tra i carbonati, i più importanti sono il carbonato di sodio Na 2 CO 3 (soda, carbonato di sodio, bicarbonato di sodio), bicarbonato di sodio NaHCO 3 (bicarbonato di sodio, bicarbonato di sodio), carbonato di potassio K 2 CO 3 (potassa) e carbonato di calcio CaCO 3 (gesso, marmo, pietra calcarea).
Reazione qualitativa per la presenza di anidride carbonica nella miscela di gas: la formazione di un precipitato di carbonato di calcio durante il passaggio del gas di prova attraverso acqua di calce (una soluzione satura di idrossido di calcio) e la successiva dissoluzione del precipitato durante l'ulteriore passaggio del gas. Reazioni che avvengono: L'elemento silicio ne forma una sostanza semplice con lo stesso nome. Questa è una sostanza non molecolare con la struttura del diamante, alla quale il silicio ha solo una durezza leggermente inferiore. Nell'ultimo mezzo secolo, il silicio è diventato un materiale assolutamente essenziale per la nostra civiltà, poiché i suoi singoli cristalli sono utilizzati in quasi tutte le apparecchiature elettroniche.
Il silicio è una sostanza abbastanza inerte. a temperatura ambiente non reagisce praticamente con nulla tranne il fluoro e l'acido fluoridrico:
Si+2F2 = SiF4;
Si + 4HF = SiF 4 + 2H 2.
Quando riscaldato sotto forma di polvere finemente macinata, brucia in ossigeno formando biossido (SiO 2). Quando fuso con alcali o bollito con soluzioni concentrate di alcali, forma silicati:
Si+4NaOH = Na4SiO4 + 2H2;
Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2.
Monossido di silicio SiO – non forma sale ossido; si ossida facilmente a biossido.
Il biossido di silicio SiO 2 è una sostanza non molecolare con una struttura a quadro. Non reagisce con l'acqua. ossido acido – se fuso con alcali, forma silicati, ad esempio:
SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O. L'alluminio è il secondo elemento più abbondante nella litosfera terrestre dopo il silicio. Da solo e insieme al silicio forma molti minerali: feldspati, miche, corindone Al 2 O 3 e le sue varietà preziose (leucosaffiro incolore, rubino contenente cromo, zaffiro contenente titanio).
La sostanza semplice alluminio è un metallo leggero lucido bianco-argenteo. L'alluminio puro è molto morbido, può essere arrotolato in un foglio sottile e da esso è possibile estrarre il filo. L'alluminio ha una buona conduttività elettrica. È resistente agli influssi atmosferici. Le leghe di alluminio sono piuttosto dure, ma possono essere lavorate bene. L'alluminio non è velenoso. Tutto ciò consente l'utilizzo dell'alluminio in un'ampia varietà di settori: nell'aviazione, nell'industria elettrica, nell'industria alimentare e nell'edilizia. L’alluminio è ampiamente utilizzato anche nella vita di tutti i giorni. L'alluminio è prodotto mediante elettrolisi della fusione dei suoi composti.
L'inerzia chimica dell'alluminio è causata dalla presenza sulla sua superficie di una densa pellicola di ossido, che impedisce il contatto del metallo con il reagente. Quando questa pellicola viene rimossa chimicamente o meccanicamente, l'alluminio diventa molto attivo. Pertanto, privo di una pellicola di ossido, l'alluminio si accende e brucia spontaneamente nell'aria senza ulteriore riscaldamento.
Le proprietà riducenti dell'alluminio sono particolarmente pronunciate quando riscaldato. In queste condizioni riduce dagli ossidi molti metalli: non solo ferro, titanio, zirconio, ma anche calcio e bario.
L'ossido di alluminio Al 2 O 3 (nomi banali - allumina, corindone) è una sostanza non molecolare, il cui legame è scarsamente descritto sia come ionico che covalente. Come sempre in questi casi si tratta di un ossido anfotero. Si ottiene per calcinazione dell'idrossido di alluminio, che ha anche proprietà anfotere.
Lo ione alluminio idratato è un acido cationico, quindi i sali di alluminio solubili sono piuttosto altamente idrolizzati.
Tra i sali di alluminio, il più comunemente usato è l'allume di potassio KAl(SO 4) 2 ·12H 2 O - solfato di alluminio e potassio dodecaidrato. È una sostanza non igroscopica, perfettamente cristallizzante. La sua soluzione si comporta come una miscela di soluzioni di due diversi solfati: solfato di potassio e solfato di alluminio. La struttura dell'allume può essere espressa dalla formula: (SO 4) 2.
1. Scrivi equazioni descrittive per le reazioni fornite nel testo del paragrafo.
2. Creare equazioni di reazione che caratterizzano le proprietà chimiche di a) alluminio, b) idrossido di alluminio, i) allume di potassio.
Proprietà chimiche dei sali di alluminio
Parole chiave dell'abstract: carbonio, silicio, elementi del gruppo IVA, proprietà degli elementi, diamante, grafite, carabina, fullerene.
Gli elementi del gruppo IV sono carbonio, silicio, germanio, stagno e piombo. Diamo uno sguardo più da vicino alle proprietà del carbonio e del silicio. La tabella mostra le caratteristiche più importanti di questi elementi.
In quasi tutti i loro composti, carbonio e silicio tetravalente , i loro atomi sono in uno stato eccitato. La configurazione dello strato di valenza di un atomo di carbonio cambia quando l'atomo è eccitato:
La configurazione dello strato di valenza dell'atomo di silicio cambia in modo simile: 
Il livello energetico esterno degli atomi di carbonio e silicio contiene 4 elettroni spaiati. Il raggio dell'atomo di silicio è maggiore; ci sono punti vuoti sul suo strato di valenza. 3 D-orbitali, ciò provoca differenze nella natura dei legami che formano gli atomi di silicio.
Gli stati di ossidazione del carbonio variano nell'intervallo da –4 a +4.
Una caratteristica del carbonio è la sua capacità di formare catene: gli atomi di carbonio si collegano tra loro e formano composti stabili. Composti simili di silicio sono instabili. La capacità del carbonio di formare catene determina l'esistenza di un numero enorme composti organici .
A composti inorganici il carbonio comprende i suoi ossidi, acido carbonico, carbonati e bicarbonati, carburi. I restanti composti del carbonio sono organici.
L'elemento carbonio è caratterizzato da allotropia, le sue modifiche allotropiche sono diamante, grafite, carbina, fullerene. Sono ora note altre modificazioni allotropiche del carbonio.
Carbone E fuliggine può essere visto come amorfo varietà di grafite.
Il silicio forma una sostanza semplice - silicio cristallino. C'è silicio amorfo - una polvere bianca (senza impurità).
Le proprietà del diamante, della grafite e del silicio cristallino sono riportate nella tabella. 
La ragione delle evidenti differenze nelle proprietà fisiche della grafite e del diamante è dovuta a differenze struttura del reticolo cristallino . In un cristallo di diamante si forma ogni atomo di carbonio (esclusi quelli sulla superficie del cristallo). quattro legami uguali e forti con gli atomi di carbonio vicini. Questi legami sono diretti verso i vertici del tetraedro (come nella molecola CH4). Pertanto, in un cristallo di diamante, ogni atomo di carbonio è circondato da quattro atomi uguali, situati ai vertici del tetraedro. La simmetria e la forza dei legami C–C in un cristallo di diamante determinano la sua eccezionale forza e mancanza di conduttività elettronica.
IN cristallo di grafite Ogni atomo di carbonio forma tre legami forti ed equivalenti con gli atomi di carbonio vicini sullo stesso piano con un angolo di 120°. Su questo piano si forma uno strato costituito da anelli piatti a sei membri.
Inoltre, ogni atomo di carbonio ha un elettrone spaiato. Questi elettroni formano un sistema elettronico comune. La connessione tra gli strati è dovuta a forze intermolecolari relativamente deboli. Gli strati sono posizionati l'uno rispetto all'altro in modo tale che l'atomo di carbonio di uno strato si trovi sopra il centro dell'esagono dell'altro strato. La lunghezza del legame C–C all'interno dello strato è 0,142 nm, la distanza tra gli strati è 0,335 nm. Di conseguenza, i legami tra gli strati sono molto più deboli dei legami tra gli atomi all’interno dello strato. Questo determina proprietà della grafite: È morbido, facile a sfaldarsi, ha un colore grigio e una lucentezza metallica, è elettricamente conduttivo ed è chimicamente più reattivo del diamante. Nella figura sono mostrati i modelli di reticoli cristallini di diamante e grafite.

È possibile trasformare la grafite in diamante? Questo processo può essere eseguito in condizioni difficili - ad una pressione di circa 5000 MPa e a temperature comprese tra 1500 °C e 3000 °C per diverse ore in presenza di catalizzatori (Ni). La maggior parte dei prodotti sono piccoli cristalli (da 1 a diversi mm) e polvere di diamante.
Carbina– modificazione allotropica del carbonio, in cui gli atomi di carbonio formano catene lineari del tipo:
–С≡С–С≡С–С≡С–(α-carabina, poliine) o =C=C=C=C=C=C=(β-carbina, poliene)
La distanza tra queste catene è inferiore rispetto a quella tra gli strati di grafite a causa delle interazioni intermolecolari più forti.
La Carbyne è una polvere nera ed è un semiconduttore. Chimicamente è più attivo della grafite.
Fullerene– modificazione allotropica del carbonio formato dalle molecole C60, C70 o C84. Sulla superficie sferica della molecola C60, gli atomi di carbonio si trovano ai vertici di 20 esagoni regolari e 12 pentagoni regolari. Tutti i fullereni sono strutture chiuse di atomi di carbonio. I cristalli di fullerene sono sostanze con una struttura molecolare.
Silicio. Esiste solo una modifica allotropica stabile del silicio, il cui reticolo cristallino è simile a quello del diamante. Il silicio è duro, refrattario ( T° pl = 1412 °C), una sostanza molto fragile di colore grigio scuro con una lucentezza metallica, in condizioni standard è un semiconduttore.
| Elemento | C | Sì | Ge | Sn | Pb |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di serie | 6 | 14 | 32 | 50 | 82 |
| Massa atomica (relativa) | 12,011 | 28,0855 | 72,59 | 118,69 | 207,2 |
| Densità (n.s.), g/cm 3 | 2,25 | 2,33 | 5,323 | 7,31 | 11,34 |
| tpl, °C | 3550 | 1412 | 273 | 231 | 327,5 |
| t kip, °C | 4827 | 2355 | 2830 | 2600 | 1749 |
| Energia di ionizzazione, kJ/mol | 1085,7 | 786,5 | 762,1 | 708,6 | 715,2 |
| Formula elettronica | 2s 2 2p 2 | 3s2 3p2 | 3d 10 4s 2 4p 2 | 4d 10 5s 2 5p 2 | 4f 14 5d 10 6s 2 6p 2 |
| Elettronegatività (secondo Pauling) | 2,55 | 1,9 | 2,01 | 1,96 | 2,33 |
Formule elettroniche dei gas nobili:
- Lui - 1s 2 ;
- Ne - 1s 2 2s 2 2p 6 ;
- Ar - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 ;
- Kr - 3d 10 4s 2 4p 6 ;
- Xe - 4d 10 5s 2 5p 6 ;
Riso. Struttura dell'atomo di carbonio.
Il gruppo 14 (gruppo IVa secondo la vecchia classificazione) della tavola periodica degli elementi chimici di D.I. Mendeleev comprende 5 elementi: carbonio, silicio, germanio, stagno, piombo (vedi tabella sopra). Il carbonio e il silicio non sono metalli, il germanio è una sostanza che presenta proprietà metalliche, lo stagno e il piombo sono metalli tipici.
L’elemento del gruppo 14(IVa) più comune nella crosta terrestre è il silicio (il secondo elemento più abbondante sulla Terra dopo l’ossigeno) (27,6% in massa), seguito da: carbonio (0,1%), piombo (0,0014%), stagno ( 0,00022%), germanio (0,00018%).
Il silicio, a differenza del carbonio, non si trova in natura in forma libera ma solo in forma legata:
- SiO 2 - silice, presente sotto forma di quarzo (parte di molte rocce, sabbia, argilla) e sue varietà (agata, ametista, cristallo di rocca, diaspro, ecc.);
- silicati ricchi di silicio: talco, amianto;
- alluminosilicati: feldspato, mica, caolino.
Anche il germanio, lo stagno e il piombo non si trovano in forma libera in natura, ma fanno parte di alcuni minerali:
- germanio: (Cu 3 (Fe, Ge)S 4) - minerale germanite;
- stagno: SnO 2 - cassiterite;
- piombo: PbS - galena; PbSO4 - angolosito; PbCO3 - cerussite.
Tutti gli elementi del gruppo 14(IVa) in uno stato non eccitato a livello energetico esterno hanno due elettroni p spaiati (valenza 2, ad esempio, CO). Quando si passa a uno stato eccitato (il processo richiede energia), un elettrone s accoppiato del livello esterno “salta” su un orbitale p libero, formando così 4 elettroni “solitari” (uno al sottolivello s e tre al livello inferiore). p-sottolivello), che espande le capacità di valenza degli elementi (la valenza è 4: ad esempio, CO 2).

Riso. Transizione di un atomo di carbonio ad uno stato eccitato.
Per questo motivo gli elementi del gruppo 14(IVa) possono presentare stati di ossidazione: +4; +2; 0; -4.
Poiché il “salto” di un elettrone dal sottolivello s al sottolivello p nella serie dal carbonio al piombo richiede sempre più energia (è necessaria molta meno energia per eccitare un atomo di carbonio che per eccitare un atomo di piombo), il carbonio “più volentieri” entra nei composti in cui la valenza è quattro; e condurre - due.
Lo stesso si può dire degli stati di ossidazione: nella serie dal carbonio al piombo, la manifestazione degli stati di ossidazione +4 e -4 diminuisce e lo stato di ossidazione +2 aumenta.
Poiché il carbonio e il silicio non sono metalli, possono presentare uno stato di ossidazione positivo o negativo, a seconda del composto (nei composti con più elementi elettronegativi, C e Si cedono elettroni e guadagnano in composti con meno elementi elettronegativi):
C +2 O, C +4 O 2, Si +4 Cl 4 C -4 H 4, Mg 2 Si -4
Ge, Sn, Pb, come i metalli nei composti, cedono sempre i loro elettroni:
Ge +4 Cl 4, Sn +4 Br 4, Pb +2 Cl 2
Gli elementi del gruppo del carbonio formano i seguenti composti:
- instabile composti volatili dell'idrogeno(formula generale EH 4), di cui solo il metano CH 4 è un composto stabile.
- ossidi non salini- ossidi inferiori CO e SiO;
- ossidi acidi- ossidi superiori CO 2 e SiO 2 - corrispondono agli idrossidi, che sono acidi deboli: H 2 CO 3 (acido carbonico), H 2 SiO 3 (acido silicico);
- ossidi anfoteri- GeO, SnO, PbO e GeO 2, SnO 2, PbO 2 - questi ultimi corrispondono agli idrossidi (IV) di germanio Ge(OH) 4, stronzio Sn(OH) 4, piombo Pb(OH) 4;