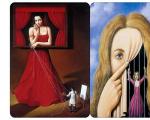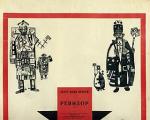Cos'è una metafora nel dominio russo. La metafora in letteratura è un confronto nascosto
Il concetto di "metafora" e approcci al suo studio
Metafora Definizione
La definizione più comune di metafora in linguistica è la seguente: “La metafora (modello metaforico) è l'accostamento di un fenomeno a un altro basato sulla prossimità semantica di stati, proprietà, azioni che caratterizzano questi fenomeni, a seguito della quale parole (frasi , frasi) destinate a designare alcuni oggetti (situazioni) della realtà sono utilizzate per denominare altri oggetti (situazioni) sulla base dell'identità condizionale dei tratti predicativi loro attribuiti” [Glazunova, 2000, p. 177-178].
Quando si utilizza una metafora, due pensieri (due concetti) su cose diverse interagiscono tra loro all'interno di una parola o espressione, il cui significato è il risultato di questa interazione.
Quattro componenti sono coinvolte nella formazione e, di conseguenza, nell'analisi di una metafora:
- due categorie di oggetti;
- proprietà di due categorie;
La metafora seleziona le caratteristiche di una classe di oggetti e le applica a un'altra classe o individuo, il vero soggetto della metafora. L'interazione con due diverse classi di oggetti e le loro proprietà crea la caratteristica principale della metafora: la sua dualità.
Una metafora vivente al momento della sua generazione e comprensione presuppone l'interazione di due denotazioni, quella che viene confrontata con qualcosa e quella con cui viene confrontata, e il nome di quest'ultima diventa il nome della prima, acquisendo un significato metaforico. La metafora del linguaggio è un fattore importante nello sviluppo del linguaggio. È lei che è alla base di molti processi linguistici, come lo sviluppo di mezzi sinonimici, l'emergere di nuovi significati e le loro sfumature, la creazione di polisemia, lo sviluppo di un vocabolario emotivamente espressivo. Includere una metafora permette di verbalizzare una rappresentazione riguardante il mondo interiore di una persona.
R. Hoffman ha scritto: “La metafora può essere utilizzata come strumento di descrizione e spiegazione in qualsiasi campo: nelle conversazioni psicoterapeutiche e nelle conversazioni tra piloti di linea, nelle danze rituali e nel linguaggio di programmazione, nell'educazione artistica e nella meccanica quantistica. La metafora, ovunque la incontriamo, arricchisce sempre la comprensione delle azioni umane, della conoscenza e del linguaggio.
Lo scienziato inglese E. Ortoni ha identificato tre ragioni principali per utilizzare la metafora nella vita di tutti i giorni:
- Ci aiutano a parlare in modo conciso.
- Rendono il nostro discorso luminoso.
- Consentono di esprimere l'inesprimibile [Ortoni, 1990, p.215].
Usiamo spesso le metafore perché sono rapide, concise, precise e comprensibili a tutti.
Classificazione delle metafore
Secondo N.D. Arutyunova, si possono distinguere i seguenti tipi di metafora linguistica:
1) nominativo metafora (trasferimento del nome), che consiste nel sostituire un significato con un altro;
2) figurativo una metafora che nasce come risultato della transizione di un significato identificativo in uno predicativo e serve lo sviluppo di significati figurativi e mezzi sinonimi del linguaggio;
3) cognitivo una metafora risultante da uno spostamento nella combinazione di parole predicative e che crea polisemia;
4) generalizzando una metafora che cancella i confini tra gli ordini logici nel significato lessicale della parola e stimola l'emergere della polisemia logica [Arutyunova, 1998, p.366].
Tipologia di metafore M.V. Nikitin si basa sul fatto che la somiglianza dei segni nelle denotazioni, che servono come base per il trasferimento del nome e la corrispondente ristrutturazione metaforica del significato diretto, può essere di natura diversa. Se la somiglianza è contenuta nelle stesse cose paragonate in modo simile, allora abbiamo a che fare con ontologico metafora: Dritto E strutturale. Quando Dritto metafore, i segni hanno la stessa natura fisica ("orso": 1. tipo di animale - goffo 2. persona goffa), e nel caso strutturale- la somiglianza c'è strutturale carattere, cioè i segni svolgono un ruolo strutturale nella natura di due denotazioni (confronta: mangiare, ricevere ospiti, ricevere informazioni). In entrambi i casi la somiglianza dei tratti è presente ancor prima del confronto e si rivela solo in esso. Quando si riscontrano segni di somiglianza negli enti confrontati, ma sono ontologicamente differenti sia per natura fisica che per ruolo strutturale, e il momento di somiglianza sorge solo durante la percezione, si parla di sinestesia E emotivo-valutativo metafore. La somiglianza qui è generata non dall'ontologia delle cose, ma dai meccanismi di elaborazione delle informazioni.
somiglianza ontologico metafore (dirette e strutturali) con sinestesia sta nel fatto che in ogni caso, ogni volta a modo suo, sulla base di qualche somiglianza, si sforzano di designare e descrivere l'oggetto di confronto secondo le proprie caratteristiche di questo oggetto. Sono contrari emotivo-valutativo una metafora che suggerisce il passaggio dal piano cognitivo della coscienza a quello pragmatico [Nikitin, 2001, pp. 37-38].
J. Lakoff e M. Johnson distinguono due tipi di metafore: ontologico, cioè metafore che ti permettono di vedere eventi, azioni, emozioni, idee, ecc. come una sorta di sostanza (la mente è un'entità, la mente è una cosa fragile), e orientata, o orientamento, cioè metafore che non definiscono un concetto in termini di un altro, ma organizzano l'intero sistema di concetti in relazione l'uno con l'altro (felice è alto, triste è basso; conscio è alto, inconscio è basso).
La grammatica può anche essere un mezzo per trasmettere un significato metaforico. Una metafora grammaticale in linguistica è intesa come un trasferimento deliberato di caratteristiche categoriche di una categoria grammaticale nell'ambito di un'altra categoria grammaticale al fine di creare un nuovo significato aggiuntivo, che non è più necessariamente grammaticale [Maslennikova, 2006, p.23].
Ci sono tre modi di metaforizzazione grammaticale:
1) Il contrasto tra il significato grammaticale della forma e il contesto;
2) Il contrasto tra il significato grammaticale della forma e il suo contenuto lessicale;
3) Il contrasto tra lessico e situazione extralinguistica.
Quando si confrontano metafora lessicale e grammaticale, si notano le seguenti differenze: la metaforizzazione in grammatica è limitata da un piccolo numero di opposizioni e un tipo chiuso di sistema grammaticale, inoltre, la metafora grammaticale è caratterizzata da unidirezionalità e non viceversa, sebbene il contrario i casi non sono esclusi.
Approcci allo studio della metafora
L'atteggiamento nei confronti della metafora sin dal suo inizio è stato ambiguo. La metafora è stata considerata da diversi punti di vista, negata, assegnandole ruoli secondari. Platone non approvava l'uso di mezzi figurativi del linguaggio, Cicerone percepiva la metafora come un'invenzione non necessaria. Per molto tempo ha prevalso questo atteggiamento negativo nei confronti della metafora.
Aristotele iniziò lo studio della metafora. I trasferimenti metaforici erano da lui considerati un significativo mezzo di linguaggio, che aveva un impatto positivo sull'ascoltatore e rafforzava l'argomento. Aristotele designava la somiglianza di due oggetti come base del trasferimento metaforico e lo considerava il principale mezzo di cognizione.
Le metafore, secondo F. Nietzsche, sono il mezzo di linguaggio più efficace, naturale, preciso e semplice [Nietzsche, 1990, p.390].
Nella retorica classica, la metafora veniva presentata principalmente come deviazione dalla norma: il trasferimento del nome di un oggetto a un altro. Lo scopo di questo trasferimento è quello di colmare l'assenza nel sistema di una lingua di un equivalente per l'unità lessicale di un'altra lingua (gap lessicale), o una sorta di "decorazione" del discorso.
In seguito, il problema della metafora si spostò dalla retorica alla linguistica. Così è nato concetto di metafora comparativa, in cui la metafora è stata posizionata come un ripensamento pittorico del solito nome. La metafora è stata presentata come un confronto nascosto. La teoria del confronto sosteneva che un'espressione metaforica implicava il confronto di due o più oggetti.
Il punto di vista tradizionale (comparativo) sulla metafora ha individuato solo alcuni approcci al metodo di formazione di una metafora e ha limitato l'uso del termine "metafora" anche solo ad alcuni dei casi che si sono presentati. Questo ci costringe a considerare la metafora solo come uno strumento linguistico, come risultato di sostituzione di parole o spostamenti contestuali, mentre la base della metafora è il prestito di idee.
Secondo M. Black, ci sono due ragioni per l'uso metaforico delle parole: l'autore ricorre a una metafora quando è impossibile trovare un equivalente diretto di un significato metaforico o quando utilizza una costruzione metaforica per scopi puramente stilistici. Il trasferimento metaforico, a suo avviso, combina l'unicità del significato semantico e il potenziale stilistico [Black, 1990, p.156].
D. Davidson ha avanzato la teoria secondo cui una metafora ha solo il suo significato diretto nel dizionario. Ed è la personalità dell'interprete che determina il significato metaforico dell'immagine [Davidson, 1990, p.174].
Una delle teorie popolari della metafora è la teoria cognitiva di J. Lakoff e M. Johnson. Secondo loro, la metaforizzazione si basa sull'interazione di due strutture di conoscenza: la struttura "fonte" e la struttura "obiettivo". Il dominio di origine nella teoria cognitiva è l'esperienza umana. L'area target è la conoscenza meno specifica, la "conoscenza per definizione". Questo approccio si è rivelato fruttuoso, poiché ha permesso di definire una metafora non solo in termini di fenomeno linguistico, ma anche come fenomeno mentale.
Un approccio cognitivo allo studio della metafora
Alla fine degli anni '70, la linguistica ha mostrato interesse per le strutture cognitive che costituiscono la base della competenza linguistica e dell'implementazione del linguaggio. È emersa una nuova direzione: la linguistica cognitiva, che è un nuovo approccio allo studio del linguaggio naturale, in cui il linguaggio è inteso come uno strumento per organizzare, elaborare e trasmettere informazioni e come una sorta di capacità umana di conoscere (insieme ad altre capacità cognitive abilità - memoria, attenzione, pensiero, percezione). La semantica occupa il posto principale in quest'area, l'oggetto principale del suo studio è il significato. Uno dei principali problemi teorici è il rapporto tra semantica e realtà. L'interesse principale dei linguisti cognitivi è concentrato in fenomeni come la prototipicità, la polisemia regolare, i modelli cognitivi e la metafora come dispositivo cognitivo universale. La teoria della metafora ha occupato un posto speciale nella linguistica cognitiva. La metafora nella linguistica moderna è considerata la principale operazione mentale, come un modo di conoscere, categorizzare, concettualizzare, valutare e spiegare il mondo. Tali scienziati, ricercatori e scrittori come D. Vico, F. Nietzsche, A. Richards, J. Ortega y Gasset, E. McCormack, P. Riker, E. Cassirer, M. Black, M. Erickson e altri [Budaev, 2007 : 16].
Durante il ripensamento metaforico nel corso del processo cognitivo, il parlante esplora parti della sua memoria a lungo termine, trova due referenti (spesso logicamente incompatibili), stabilisce tra loro una relazione significativa e, quindi, crea una metafora. Una relazione significativa viene stabilita sulla base della scoperta di una serie di caratteristiche comuni a due referenti. Queste caratteristiche si riflettono nella struttura del significato lessicale.
Poiché il significato lessicale di una parola è eterogeneo, è interessante analizzare quale parte del significato è soggetta a ripensamento metaforico, quali caratteristiche semantiche sono alla base della formazione di un nuovo significato metaforico. Nella struttura del significato lessicale di una parola, dal punto di vista dell'aspetto conoscitivo, si possono distinguere due parti: l'intensione e l'implicazione. Un'intensione è un insieme di caratteristiche semantiche (semi) che una denotazione deve avere per essere inclusa in una data classe. L'implicazionale è anche un insieme di caratteristiche semantiche, ma un insieme formato associativamente dall'intensione. Nel ripensamento metaforico delle parole, in primo luogo, i tratti implicazionali (non esclusi quelli intensionali) sono coinvolti nella ristrutturazione della semantica della parola. Una parte di questi segni costituisce il contenuto della parte differenziale del significato metaforico derivato [Nikitin, 2001, p.36].
La parola non ha un elenco finito di significati, ma esiste un certo significato iniziale del modello di derivazione semantica che ha generato un certo numero di significati che possono generare un numero non finito di significati prodotti. Tuttavia, significati diversi hanno una diversa possibilità di diventare realtà. Ci sono due punti che determinano la possibilità di realizzare l'uno o l'altro significato di una data parola. Questi sono: 1. la necessità della nomina del concetto corrispondente e 2. la forza, la luminosità della connessione associativa di due concetti (originale e figurativamente denotata). La combinazione di questi fattori aumenta la possibilità di realizzare un valore derivato. È possibile giudicare oggettivamente il potenziale metaforico delle parole solo sulla base di casi registrati del loro uso figurativo sulla base di analoghe somiglianze, tenendo conto delle metafore. In definitiva, tutto si riduce a confrontare concetti cognitivamente equivalenti dal modo in cui sono espressi, diretti o figurativi [Nikitin, 2001, p.43-44].
Un posto speciale nello sviluppo della teoria cognitiva è dato a J. Lakoff e M. Johnson. È in esso che la metafora come oggetto di studio viene tradotta in un paradigma logico-cognitivo e studiata dal punto di vista della sua connessione con le strutture cognitive profonde e il processo di categorizzazione del mondo, hanno sviluppato una teoria che ha introdotto un certo sistema nella descrizione del meccanismo cognitivo della metafora e ha fornito un gran numero di esempi che confermano questa teoria. L'idea chiave di J. Lakoff e M. Johnson è che le metafore come espressioni linguistiche diventano possibili grazie al fatto che il sistema concettuale umano è metaforico nella sua base. Cioè, comprendere e sperimentare fenomeni di un tipo in termini di fenomeni di un altro tipo è una proprietà fondamentale del nostro pensiero. “La metafora permea tutta la nostra vita quotidiana e si manifesta non solo nel linguaggio, ma anche nel pensiero e nell'azione. Il nostro sistema concettuale quotidiano, all'interno del quale pensiamo e agiamo, è metaforico nella sua stessa essenza” [Lakoff, 1990, p.387]. Sviluppando il suo concetto, J. Lakoff è partito dal fatto che molte affermazioni riguardanti la metafora risultano false:
- Qualsiasi argomento può essere preso alla lettera, senza metafora.
- L'uso più comune della metafora è nella poesia.
- Le metafore sono solo espressioni linguistiche.
- Le espressioni metaforiche sono intrinsecamente non vere.
- Solo il linguaggio letterale può essere veritiero [Lakoff, 1990, p. 390].
Aderendo al punto di vista di J. Lakoff sulla teoria cognitiva della metafora, la sua idea principale può essere espressa come segue: la base del processo di metaforizzazione è l'interazione di due domini concettuali: il dominio di origine e il dominio di destinazione. Come risultato della proiezione metaforica dalla sfera sorgente alla sfera bersaglio, gli elementi della sfera sorgente formati come risultato dell'esperienza dell'interazione umana con il mondo esterno strutturano una sfera bersaglio meno comprensibile, che è l'essenza del potenziale cognitivo della metafora. La sfera di origine è una conoscenza più concreta, è più facile da trasferire da una persona all'altra, si basa direttamente sull'esperienza dell'interazione umana con la realtà, mentre la sfera di destinazione è una conoscenza meno concreta, meno definita. La fonte fondamentale di conoscenza che costituisce i domini concettuali è l'esperienza dell'interazione umana con il mondo esterno. Le stabili corrispondenze tra la sfera sorgente e la sfera bersaglio, fissate nella tradizione linguistica e culturale della società, sono state chiamate "metafore concettuali".
Seguendo J. Lakoff, E. Budaev osserva che “l'affermazione che il soggetto è incline a rispondere non alla realtà, ma piuttosto alle proprie rappresentazioni cognitive della realtà, porta alla conclusione che il comportamento umano è direttamente determinato non tanto dalla realtà oggettiva come dal sistema di rappresentanza persona. Ne consegue che le conclusioni che traiamo sulla base del pensiero metaforico possono costituire la base per le azioni” [Budaev, 2007, p.19].
Il dominio di origine è la nostra esperienza fisica, ma può anche coinvolgere valori culturali comuni. La sfera target è ciò su cui attualmente stiamo concentrando la nostra attenzione, ciò che stiamo cercando di capire.
Un noto esempio di J. Lakoff è la metafora L'ARGOMENTO È LA GUERRA, che rappresenta la comprensione di una disputa come una guerra. Nel linguaggio comune, questa metafora si realizza in una serie di affermazioni in cui la disputa è denotata in termini militari:
Tuo affermazioni Sono indifendibile.
Le tue affermazioni non resistono al controllo (lett. indifendibile).
La disputa e la guerra sono fenomeni di ordine diverso, in ognuno dei quali si compiono azioni diverse. Una discussione è uno scambio orale di osservazioni, una guerra è un conflitto, con l'uso delle armi. Ma confrontiamo la disputa con la guerra, usando la sua terminologia. È importante notare che non stiamo solo usando termini militari in una discussione. La persona con cui stiamo discutendo, la presentiamo come un avversario, vinciamo o perdiamo in una discussione. Avanziamo o ci ritiriamo, abbiamo un certo piano (strategia). Una discussione è una battaglia verbale. Pertanto, il concetto è ordinato metaforicamente, l'attività corrispondente è ordinata metaforicamente e, di conseguenza, anche il linguaggio è ordinato metaforicamente. Ma se, come suggerisce J. Lakoff, proviamo a immaginare un'altra cultura in cui le controversie sono interpretate non in termini di guerra, ma, ad esempio, in termini di danza, allora i rappresentanti di quella cultura considereranno le controversie in modo diverso, le condurranno in modo diverso e parlarne in modo diverso. Pertanto, J. Lakoff illustra l'idea principale: "L'essenza di una metafora è comprendere e sperimentare fenomeni di un tipo in termini di fenomeni di un altro tipo".
Parliamo di una disputa in questo modo perché pensiamo in questo modo. Il trasferimento metaforico non è limitato dalle barriere linguistiche e può essere effettuato non solo a livello verbale, ma anche associativo-figurativo. Di conseguenza, viene rivelata la conclusione più importante: "La metafora non è limitata alla sola sfera del linguaggio, cioè alla sfera delle parole: i processi stessi del pensiero umano sono in gran parte metaforici" [Lakoff, 1990, p.23] .
Nella tipologia dei ricercatori americani, le metafore concettuali possono essere suddivise in altri due tipi: metafore orientative E metafore ontologiche.
Nelle metafore ontologiche, ordiniamo un concetto in termini di un altro, mentre le metafore orientative riflettono opposizioni che riflettono e fissano la nostra esperienza di orientamento spaziale nel mondo (Happy is up, sad is down). In altre parole, lo spazio risulta essere uno dei concetti base per la formazione e la designazione di un'esperienza diversa, non spaziale. Nell'opera "Metaphors we live by", J. Lakoff fornisce esempi di modellazione di vari tipi di esperienza come concetti spaziali che costituiscono la base delle metafore orientative:
- FELICE È SU, TRISTE È GIÙ
La base fisica della metafora HAPPY IS UP, SAD IS DOWN è l'idea che, essendo in uno stato triste, una persona abbassa la testa, mentre, provando emozioni positive, una persona si raddrizza e alza la testa.
mi sento su. Lo è davvero Basso in questi giorni.
Quello potenziato i miei spiriti. mi sento giù.
Pensare a lei mi dà sempre un sollevare. i miei spiriti affondò.
Sulla base del materiale linguistico, Lakoff e Johnson traggono le conclusioni appropriate sui fondamenti, la connessione e la natura sistemica dei concetti metaforici:
- La maggior parte dei nostri concetti fondamentali sono organizzati in termini di una o più metafore orientative.
- Ogni metafora spaziale ha una consistenza interna.
- Una varietà di metafore orientative sono abbracciate da un sistema comune che le armonizza l'una con l'altra.
- Le metafore orientative sono radicate nell'esperienza fisica e culturale e non sono applicate per caso.
- Le metafore possono essere basate su vari fenomeni fisici e sociali.
- In alcuni casi, l'orientamento nello spazio è una parte così essenziale del concetto che è difficile per noi immaginare qualsiasi altra metafora che possa semplificare il concetto.
- I cosiddetti concetti puramente intellettuali sono spesso, e possibilmente sempre, basati su metafore che hanno una base fisica e/o culturale [Lakoff, 2004, p.30-36].
Le metafore ontologiche, d'altra parte, dividono entità astratte in determinate categorie, delineandone i confini nello spazio o le personificano. “Proprio come i dati dell'esperienza umana nell'orientamento spaziale danno origine a metafore orientative, i dati della nostra esperienza associati agli oggetti fisici costituiscono la base per una colossale varietà di metafore ontologiche, cioè modi di interpretare eventi, azioni, emozioni, idee , eccetera. come oggetti e sostanze” [Lakoff, 2004, p.250]. (Stiamo lavorando per pace. Il lato brutto della sua personalità esce sotto pressione. Non riesco a tenere il passo con il ritmo della vita moderna.)
J. Lakoff evidenzia anche la metafora del condotto. La sua essenza è la seguente: il parlante mette idee (oggetti) in parole (recipienti) e le invia (tramite un canale di comunicazione - condotto) all'ascoltatore, che estrae idee (oggetti) dalle parole (recipienti).
Il linguaggio che usiamo quando parliamo del linguaggio stesso è strutturalmente ordinato secondo la seguente metafora composta:
LE IDEE (O SIGNIFICATI) SONO OGGETTI.
LE ESPRESSIONI LINGUISTICHE SONO IL CONTENITORE.
LA COMUNICAZIONE È UNA TRASMISSIONE (PARTENZA).
Dalla prima proposizione di questa metafora - I VALORI SONO OGGETTI - ne consegue, in particolare, che i significati esistono indipendentemente dalle persone e dai contesti d'uso.
Dalla seconda componente della metafora del CANALE DI COMUNICAZIONE - LE ESPRESSIONI LINGUISTICHE SONO UN RISERVO DI SIGNIFICATI - ne consegue che le parole e le frasi hanno un significato in sé - indipendentemente dal contesto o da chi parla. Un esempio di schema figurativo di IDEE - QUESTI OGGETTI possono essere le seguenti espressioni:
È difficile fargli capire un'idea.
È difficile per lui spiegare (qualsiasi) pensiero.
Ti ho dato quell'idea.
Ti ho dato questa idea.
La teoria proposta da J. Lakoff e M. Johnson ha ricevuto un ampio riconoscimento nella scienza, è stata attivamente sviluppata in molte scuole e direzioni [Lakoff, 2008, p.65].
M. Johnson usa il termine schema figurativo(o schema immagine, schema immagine) per una tale struttura schematica attorno alla quale è organizzata la nostra esperienza. Il suo concetto di schema figurativo risale al concetto di schema di Kant, ma ne differisce. Johnson definisce uno schema figurativo come segue: “Lo schema figurativo è uno schema dinamico ricorrente (pattern) dei nostri processi percettivi e dei nostri programmi motori, che dà coerenza e struttura alla nostra esperienza” [Chenki, 2002, p.350]. Johnson non afferma che sia possibile compilare un elenco di tutti gli schemi di immagini utilizzati nell'esperienza quotidiana, ma offre un elenco parziale di ventisette schemi di immagini per dare un'idea della loro diversità. In generale, gli schemi figurativi sono caratterizzati dalle seguenti qualità:
- non propositivo;
- non sono associati a una sola forma di percezione;
- fanno parte della nostra esperienza a livello di percezione, immaginazione e struttura degli eventi;
- assicura la coerenza dell'esperienza umana attraverso diversi tipi di cognizione, dal livello dell'individuo al livello delle strutture sociali;
- sono strutture della Gestalt (esistono come interi unificati coerenti e significativi nella nostra esperienza e cognizione) [Chenki, 2002, p.354].
Uno schema figurativo o topologico è un tipico modello (modello) applicabile alla descrizione di molte unità linguistiche contemporaneamente. Tuttavia, non tutti i concetti possono essere "assemblati" da tali schemi semantici primari, perché ciascuno di essi fa appello alle forme o ai movimenti più semplici del corpo umano, che sono familiari e comprensibili a un madrelingua e che, quindi, può facilmente trasferire alla realtà circostante. C'è una "legatura" antropocentrica dei principali "mattoni", frammenti della rappresentazione semantica. Si basa sull'idea di Lakoff, che si chiama incarnazione (incarnazione nel corpo umano) e riporta la linguistica ai tempi delle teorie locali: non solo associata a una persona, ma solo associata alle sue sensazioni spaziali e reazioni motorie è riconosciuta come primaria. C'è anche un insieme di concetti astratti che possono essere ridotti a schemi di immagini: "quantità", "tempo", "spazio", "causalità", ecc.; questi concetti, a loro volta, possono essere alla base di altri, più astratti o, al contrario, oggettivi, ma in tutti i casi, per il fatto che la primissima, iniziale semantizzazione di essi si basa sul passaggio dal concreto all'astratto, e inoltre, dallo spazio a tutto il resto, i significati spaziomotori sono sempre primari. È questa connessione diretta con le più semplici "primitive" spaziali che ci spinge a tradurre il termine schema immagine non come schema figurativo, ma come schema topologico. Questa traduzione, in primo luogo, sottolinea che gli schemi figurativi sono alla base di tutte le "immagini" cognitive e, in secondo luogo, sottolinea l'idea localista [Rakhilina, 2000, p.6].
Riassumendo quanto sopra, possiamo trarre le seguenti conclusioni sull'interpretazione della metafora nella linguistica cognitiva. La metafora non è solo uno strumento linguistico che ti consente di decorare il discorso e rendere l'immagine più comprensibile, è una forma di pensiero. Secondo l'approccio cognitivo alla natura del pensiero umano, il sistema concettuale di una persona è condizionato dalla sua esperienza fisica. E il pensiero è figurativo, cioè per rappresentare concetti che non sono condizionati dall'esperienza, una persona usa un paragone, una metafora. La capacità di una tale persona di pensare in senso figurato determina la possibilità del pensiero astratto.
Elenco bibliografico
- Glazunova O.I. La logica delle trasformazioni metaforiche. - San Pietroburgo: Facoltà di Filologia // State University, 2002. - P. 177-178.
- Hoffman RR Cosa potrebbero dirci gli studi sui tempi di reazione sulla comprensione delle metafore? // Metafora e attività simbolica, 1987. - Pp. 152.
- Ortoni E. Il ruolo della somiglianza nell'assimilazione e nella metafora // Teoria della metafora / Otv. ed. ND Arutyunov. - M.: Casa editrice "Progress", 1990. - S. 215.
- Arutyunova N.D. Il linguaggio e il mondo umano. - M.: Lingue della cultura russa, 1998. - S. 366.
- Nikitin MB Potenziale metaforico della parola e sua realizzazione // Il problema della teoria delle lingue europee / Ed. ed. V.M. Arinstein, N.A. Abieva, L.B. Kopchuk. - San Pietroburgo: casa editrice Trigon, 2001. - S. 37-38.
- Maslennikova A.A. Caratteristiche della metafora grammaticale // Metafore del linguaggio e metafore nel linguaggio / A.I. Varshavskaya, A.A. Maslennikova, E.S. Petrova e altri / Ed. AV Zelenshchikova, A.A. Maslennikova. San Pietroburgo: Università statale di San Pietroburgo, 2006. - P. 23.
- Nietzsche F. Al di là del bene e del male. Libro. 2. - Casa editrice italo-sovietica SIRIN, 1990. - P. 390.
- Black M. Metafora // Teoria della metafora / Otv. ed. ND Arutyunov. - M.: Progress Publishing House, 1990. - P. 156.
- Davidson D. Cosa significano le metafore // Teoria della metafora / Otv. ed. ND Arutyunov. - M.: Progress Publishing House, 1990. - P.174.
- Budaev E.V. Formazione della teoria cognitiva della metafora // Lingvokultorologiya. - 2007. - N. 1. - Pagina 16.
- Nikitin M.V. Concetto e metafora // Il problema della teoria delle lingue europee / Ed. ed. V.M. Arinstein, N.A. Abieva, L.B. Kopchuk. - San Pietroburgo: casa editrice Trigon, 2001. - P.36.
- Nikitin MB Potenziale metaforico della parola e sua realizzazione // Il problema della teoria delle lingue europee / Ed. ed. V.M. Arinstein, N.A. Abieva, L.B. Kopchuk. - San Pietroburgo: casa editrice Trigon, 2001. - S. 43-44.
- Lakoff J. Metafore in base alle quali viviamo. - M.: Casa editrice LKI, 1990. - S. 387.
- Lakoff J. Metafore in base alle quali viviamo. - M.: Casa editrice LKI, 2008. - S. 390.
- Lakoff G. La teoria contemporanea della metafora // Metafora e pensiero / Ed. Di A. Ortony. – Cambridge, 1993. – pp. 245.
- Budaev E.V. Formazione della teoria cognitiva della metafora // Lingvokultorologiya. - 2007. - N. 1. – P. 19.
- Lakoff G., Johnson M. Metafore in base alle quali viviamo. – Chicago, 1980. – pp. 23.
- Lakoff J. Metafore in base alle quali viviamo. - M.: Casa editrice LKI, 1990. - S. 23.
- Lakoff J. Donne, fuoco e cose pericolose: cosa ci dicono le categorie del linguaggio sul pensiero. - M.: Lingue della cultura slava, 2004. - S. 30 -36.
- Lakoff J. Donne, fuoco e cose pericolose: cosa ci dicono le categorie del linguaggio sul pensiero. - M.: Lingue della cultura slava, 2004. - S. 250.
- Lakoff J. Metafore in base alle quali viviamo. - M.: Casa editrice LKI, 2008. - S. 65.
- Chenki A. Semantica nella linguistica cognitiva // Linguistica americana moderna: tendenze fondamentali / Ed. ed. AA. Kibrik, IM Kobozeva, IA Sekerina. - M.: Casa editrice "Editorial", 2002. - S. 350.
- Chenki A. Semantica nella linguistica cognitiva // Linguistica americana moderna: tendenze fondamentali / Ed. ed. AA. Kibrik, IM Kobozeva, IA Sekerina. - M .: Casa editrice "Editorial", 2002. - S. 354.
- Rachilina E.V. Sulle tendenze nello sviluppo della semantica cognitiva // Literature and Language Series, 2000. - N. 3. – P.6.
Cominciò a essere percepito come una parte separata del discorso nel 20 ° secolo, quando la portata dell'uso di questa tecnica artistica si espanse, il che portò all'emergere di nuovi generi di letteratura. - allegorie, proverbi e indovinelli.
Funzioni
In russo, come in tutti gli altri, metafora svolge un ruolo importante e svolge i seguenti compiti principali:
- dando la dichiarazione emotività e colorazione figurativamente espressiva;
- costruzione del vocabolario nuove costruzioni e frasi lessicali(funzione nominativa);
- luminoso insolito immagini rivelatrici ed essenza.
A causa dell'ampio utilizzo di questa figura, sono apparsi nuovi concetti. Quindi, metaforicamente significa mezzi espressi allegoricamente, figurativamente, figurativamente e metaforicamente usati in senso indiretto e figurato. Il metaforismo è l'uso di metafore per rappresentare qualcosa..

Varietà
Spesso ci sono difficoltà su come definire un dato espediente letterario e distinguerlo dagli altri. Definisci metafora possibile per disponibilità:
- somiglianze nella disposizione spaziale;
- somiglianza nella forma (il cappello di una donna è un cappello vicino a un chiodo);
- somiglianza esterna (ago da cucito, ago di abete rosso, ago da riccio);
- il trasferimento di qualsiasi segno di una persona su un oggetto (una persona muta - un film muto);
- somiglianza di colore (collana d'oro - autunno d'oro);
- somiglianza di attività (una candela brucia - una lampada brucia);
- somiglianza della posizione (la suola dello stivale - la suola della roccia);
- somiglianze tra uomo e animale (pecora, maiale, asino).
Tutto quanto sopra è la conferma che si tratta di un confronto nascosto. Suggerito classificazione indica quali tipi di metafore dipendono dalla somiglianza dei concetti.
Importante! La tecnica artistica ha le sue specifiche in diverse lingue, quindi il significato potrebbe differire. Quindi, l '"asino" tra i russi è associato alla testardaggine e, ad esempio, tra gli spagnoli, al duro lavoro.
mezzi espressivi classificati in base a vari parametri. Offriamo una versione classica che esiste fin dall'antichità.
La metafora potrebbe essere:
- affilato- basato su un confronto di concetti diversi, quasi incompatibili: il ripieno dell'affermazione.
- Cancellato- uno che non è considerato un fatturato figurativo: la gamba del tavolo.
- Hanno la forma di una formula- simile a quello cancellato, ma ha bordi più sfocati di figuratività, l'espressione non figurativa in questo caso è impossibile: il verme del dubbio.
- Implementato- quando si utilizza un'espressione, il suo significato figurativo non viene preso in considerazione. Spesso realizzato da dichiarazioni comiche: "Ho perso la pazienza e sono salito sull'autobus".
- Metafora estesa- un giro di parole, che si costruisce sulla base dell'associazione, si realizza in tutta l'enunciazione, è comune in letteratura: "La fame di libri non se ne va: i prodotti del mercato dei libri sono sempre più stantii ...". Occupa anche un posto speciale nella poesia: "Qui il vento abbraccia uno stormo di onde con un forte abbraccio e le lancia su larga scala con rabbia selvaggia contro le scogliere ..." (M. Gorky).
A seconda del grado di prevalenza, ci sono:
- comunemente usato secco
- figurativo comune,
- poetico,
- figurato di giornale,
- diritto d'autore figurativo.

Esempi di espressioni
La letteratura è piena di frasi con esempi di metafore in russo:
- "Un fuoco di cenere di montagna rossa arde nel giardino" (S. Yesenin).
- "Finché bruciamo di libertà, mentre i nostri cuori sono vivi per l'onore ..." (A. Pushkin)
- "Lei canta - ei suoni si stanno sciogliendo ..." (M. Lermontov) - i suoni si stanno sciogliendo;
- "... L'erba piangeva ..." (A.) - l'erba piangeva;
- "Era un periodo d'oro, ma era nascosto" (A. Koltsov) - un periodo d'oro;
- "L'autunno della vita, come l'autunno dell'anno, deve essere accolto con gratitudine" (E. Ryazanov) - l'autunno della vita;
- "Gli alfieri hanno infilato gli occhi nello zar" (A. Tolstoy) - hanno infilato gli occhi.
Questa è una delle immagini più usate nel discorso. Un posto speciale è occupato dalla poesia, dove le immagini vengono alla ribalta.. In alcune opere, questi giri di parole si verificano durante la storia.
Vividi esempi di metafora in letteratura: notte fonda, testa d'oro, guanti da riccio, mani d'oro, carattere di ferro, cuore di pietra, come un gatto che piangeva, quinta ruota di un carro, presa del lupo.
Metafora
Da dove viene la metafora? [Lezioni di letteratura]
Conclusione
La tecnica per trasferire qualità simili da un concetto all'altro è spesso usata nel linguaggio quotidiano. Anche trovare molti esempi nella narrativa, nella prosa e nella poesia non è difficile, perché questo modo di parlare è il principale in ogni opera letteraria.
Una metafora è un'espressione o una parola in senso figurato, la cui base è un fenomeno o un oggetto che ha una somiglianza con esso. In parole semplici, una parola viene sostituita da un'altra che ha un segno simile con essa.
La metafora in letteratura è una delle più antiche
Cos'è una metafora
La metafora ha 4 parti:
- Contesto - un passaggio completo di testo che combina il significato delle singole parole o frasi incluse in esso.
- Un oggetto.
- Il processo mediante il quale viene eseguita la funzione.
- Applicazione di questo processo o della sua intersezione con qualsiasi situazione.
Il concetto di metafora è stato scoperto da Aristotele. Grazie a lui, ora si è formata una visione su di esso come accessorio necessario del linguaggio, che consente di raggiungere obiettivi cognitivi e di altro tipo.
I filosofi antichi credevano che la metafora ci fosse stata data dalla natura stessa ed era così consolidata nel linguaggio quotidiano che molti concetti non avevano bisogno di essere chiamati letteralmente, e il suo uso riempiva la mancanza di parole. Ma dopo di loro, è stata assegnata la funzione di un'applicazione aggiuntiva al meccanismo della lingua, e non alla sua forma principale. Si credeva che per la scienza fosse addirittura dannoso, perché conduce a un vicolo cieco nella ricerca della verità. Contro ogni previsione, la metafora ha continuato a esistere in letteratura perché era necessaria al suo sviluppo. Era usato principalmente nella poesia.
Solo nel 20 ° secolo la metafora è stata finalmente riconosciuta come parte integrante del discorso e la ricerca scientifica che la utilizzava ha iniziato a essere condotta in nuove dimensioni. Ciò è stato facilitato da una proprietà come la capacità di combinare materiali di diversa natura. in letteratura è diventato chiaro quando hanno visto che l'uso esteso di questa tecnica artistica porta alla comparsa di enigmi, proverbi, allegorie.

Costruire una metafora
La metafora è creata da 4 componenti: due gruppi e proprietà di ciascuno di essi. Le funzionalità di un gruppo di oggetti vengono offerte a un altro gruppo. Se una persona viene chiamata leone, si presume che sia dotata di caratteristiche simili. Viene così creata una nuova immagine, dove la parola "leone" in senso figurato significa "senza paura e potente".
Le metafore sono specifiche per le diverse lingue. Se l '"asino" dei russi simboleggia la stupidità e la testardaggine, allora gli spagnoli - la diligenza. Una metafora in letteratura è un concetto che può differire tra i diversi popoli, che dovrebbe essere preso in considerazione quando si traduce da una lingua all'altra.
Funzioni metaforiche
La funzione principale della metafora è una vivida valutazione emotiva e una colorazione figurativamente espressiva del discorso. Allo stesso tempo, da oggetti incomparabili vengono create immagini ricche e capienti.
Un'altra funzione è nominativa, che consiste nel riempire la lingua di costruzioni fraseologiche e lessicali, ad esempio: collo di bottiglia, viole del pensiero.
Oltre a quelle principali, la metafora svolge molte altre funzioni. Questo concetto è molto più ampio e ricco di quanto sembri a prima vista.
Cosa sono le metafore
Sin dai tempi antichi, le metafore sono state suddivise nei seguenti tipi:
- Nitido: concetti di collegamento che giacciono su piani diversi: "Sto camminando per la città, girato con i miei occhi ...".
- Cancellato - così banale che il carattere figurativo non si nota più ("Già al mattino per me la gente si stava avvicinando"). È diventato così familiare che il significato figurativo è difficile da afferrare. Si trova quando si traduce da una lingua all'altra.
- Metafora-formula: è esclusa la sua trasformazione in un significato diretto (il verme del dubbio, la ruota della fortuna). È diventata uno stereotipo.
- Espanso: contiene un messaggio di grandi dimensioni in una sequenza logica.
- Implementato - utilizzato per lo scopo previsto (" Sono tornato in me, e di nuovo un vicolo cieco).

È difficile immaginare la vita moderna senza immagini metaforiche e confronti. La metafora più comune in letteratura. Ciò è necessario per una vivida divulgazione delle immagini e dell'essenza dei fenomeni. In poesia, la metafora estesa è particolarmente efficace, presentata nei seguenti modi:
- Uso della comunicazione indiretta o storia usando il confronto.
- Una figura retorica che utilizza parole in senso figurato, basata su analogia, somiglianza e confronto.
Coerentemente divulgato nel frammento di testo: “ Una pioggia fine con l'alba lava l'alba», « La luna regala sogni di Capodanno».
Alcuni classici credevano che una metafora in letteratura fosse un fenomeno separato che acquisisce un nuovo significato a causa del suo verificarsi. In questo caso diventa l'obiettivo dell'autore, dove l'immagine metaforica conduce il lettore a un nuovo significato, un significato inaspettato. Tali metafore della finzione possono essere trovate nelle opere dei classici. Prendiamo, ad esempio, il Naso, che acquista un significato metaforico nella storia di Gogol. Ricco di immagini metaforiche dove danno un nuovo significato a personaggi ed eventi. Sulla base di ciò, si può affermare che la loro definizione diffusa è tutt'altro che completa. La metafora in letteratura è un concetto più ampio e non solo decora il discorso, ma spesso gli conferisce un nuovo significato.

Conclusione
Cos'è la metafora in letteratura? Ha un effetto più efficace sulla coscienza grazie alla sua colorazione emotiva e alle sue immagini. Ciò è particolarmente evidente nella poesia. L'impatto della metafora è così forte che gli psicologi la usano per risolvere problemi legati alla psiche dei pazienti.
Le immagini metaforiche vengono utilizzate durante la creazione di annunci pubblicitari. Stimolano l'immaginazione e aiutano i consumatori a fare la scelta giusta. Lo stesso viene svolto anche dalla società nella sfera politica.
La metafora sta entrando sempre più nella vita di tutti i giorni, manifestandosi nel linguaggio, nel pensiero e nell'azione. Il suo studio si sta espandendo, coprendo nuove aree di conoscenza. Dalle immagini create dalle metafore, si può giudicare l'efficacia di un particolare mezzo.
Ed è connesso con la sua comprensione dell'arte come imitazione della vita. La metafora di Aristotele, in sostanza, è quasi indistinguibile dall'iperbole (esagerazione), dalla sineddoche, dal semplice paragone o personificazione e similitudine. In tutti i casi, c'è un trasferimento di significato da una parola all'altra.
- Un messaggio indiretto sotto forma di una storia o di un'espressione figurativa che utilizza il confronto.
- Una figura retorica consistente nell'uso di parole ed espressioni in senso figurato basato su una sorta di analogia, somiglianza, confronto.
Ci sono 4 "elementi" nella metafora
- categoria o contesto,
- Un oggetto all'interno di una categoria specifica,
- Il processo mediante il quale questo oggetto esegue una funzione,
- Applicazioni di questo processo a situazioni reali o intersezioni con esse.
- Una metafora tagliente è una metafora che riunisce concetti che sono molto distanti. Modello: dichiarazioni di riempimento.
- Una metafora cancellata è una metafora generalmente accettata, la cui natura figurativa non è più percepita. Modello: gamba della sedia.
- La formula-metafora è vicina alla metafora cancellata, ma ne differisce per uno stereotipo ancora maggiore e talvolta per l'impossibilità di convertirsi in una costruzione non figurativa. Modello: dubbio verme.
- Una metafora estesa è una metafora implementata in modo coerente su un ampio frammento di un messaggio o sull'intero messaggio nel suo insieme. Modello: La fame di libri continua: i prodotti del mercato dei libri sono sempre più stantii - devono essere buttati via senza nemmeno provarci.
- Una metafora realizzata implica operare un'espressione metaforica senza tener conto della sua natura figurativa, cioè come se la metafora avesse un significato diretto. Il risultato della realizzazione di una metafora è spesso comico. Modello: ho perso la pazienza e sono salito sull'autobus.
teorie
Tra gli altri tropi, la metafora occupa un posto centrale, in quanto consente di creare immagini capienti basate su associazioni vivide e inaspettate. Le metafore possono essere basate sulla somiglianza delle più diverse caratteristiche degli oggetti: colore, forma, volume, scopo, posizione, ecc.
Secondo la classificazione proposta da N. D. Arutyunova, le metafore sono suddivise in
- nominativo, consistente nel sostituire un significato descrittivo con un altro e servire come fonte di omonimia;
- metafore figurative che servono allo sviluppo di significati figurativi e mezzi sinonimi del linguaggio;
- metafore cognitive risultanti da uno spostamento nella combinazione di parole predicative (trasferimento di significato) e creazione di polisemia;
- generalizzare le metafore (come risultato finale di una metafora cognitiva), cancellare i confini tra gli ordini logici nel significato lessicale della parola e stimolare l'emergere della polisemia logica.
Diamo un'occhiata più da vicino alle metafore che contribuiscono alla creazione di immagini o figurative.
In senso lato, il termine "immagine" significa un riflesso nella mente del mondo esterno. In un'opera d'arte, le immagini sono l'incarnazione del pensiero dell'autore, la sua visione unica e l'immagine vivida dell'immagine del mondo. La creazione di un'immagine vivida si basa sull'uso della somiglianza tra due oggetti distanti tra loro, quasi su una sorta di contrasto. Affinché il confronto di oggetti o fenomeni sia inaspettato, devono essere abbastanza diversi l'uno dall'altro, e talvolta la somiglianza può essere del tutto insignificante, impercettibile, dare spunti di riflessione o può essere del tutto assente.
I confini e la struttura dell'immagine possono essere praticamente qualsiasi cosa: l'immagine può essere veicolata da una parola, una frase, una frase, un'unità soprafrasale, può occupare un intero capitolo o coprire la composizione di un intero romanzo.
Tuttavia, ci sono altri punti di vista sulla classificazione delle metafore. Ad esempio, J. Lakoff e M. Johnson distinguono due tipi di metafore considerate in relazione al tempo e allo spazio: ontologiche, cioè metafore che consentono di vedere eventi, azioni, emozioni, idee, ecc. come una sorta di sostanza ( la mente è un'entità, la mente è una cosa fragile), e orientato, o orientativo, cioè metafore che non definiscono un concetto in termini di un altro, ma organizzano l'intero sistema di concetti in relazione l'uno con l'altro ( felice è su, triste è giù; il conscio è su, l'inconscio è giù).
George Lakoff nella sua opera "The Contemporary Theory of Metaphor" parla dei modi di creare una metafora e della composizione di questo mezzo di espressione artistica. La metafora, secondo la teoria di Lakoff, è un'espressione in prosa o poetica, dove una parola (o più parole), che è un concetto, è usata in senso indiretto per esprimere un concetto simile a questo. Lakoff scrive che nella prosa o nel discorso poetico la metafora si trova al di fuori della lingua, nel pensiero, nell'immaginazione, riferendosi a Michael Reddy, la sua opera "The Conduit Metaphor", in cui Reddy nota che la metafora risiede nella lingua stessa, in discorso quotidiano, e non solo in poesia o in prosa. Reddy afferma anche che "l'oratore mette le idee (oggetti) in parole e le invia all'ascoltatore, che estrae le idee / oggetti dalle parole". Questa idea si riflette anche nello studio di J. Lakoff e M. Johnson "Metafore con cui viviamo". I concetti metaforici sono sistemici, “la metafora non si limita alla sola sfera del linguaggio, cioè alla sfera delle parole: i processi stessi del pensiero umano sono in gran parte metaforici. Le metafore come espressioni linguistiche diventano possibili proprio perché ci sono metafore nel sistema concettuale umano.
La metafora è spesso considerata come uno dei modi per riflettere accuratamente la realtà in termini artistici. Tuttavia, I. R. Galperin afferma che “questo concetto di accuratezza è molto relativo. È una metafora che crea un'immagine specifica di un concetto astratto che rende possibile interpretare i messaggi reali in modi diversi.
Nervi di ferro, cuore di ghiaccio e mani d'oro facevano invidia a tutti di nera invidia. Ti piacciono quattro metafore in una frase?
Buon giorno, cari lettori, se siete approdati sul mio sito, allora volete imparare qualcosa di nuovo su come scrivere determinati testi, promuovere il vostro sito o informazioni simili. Oggi parleremo di cos'è una metafora, impareremo a crearne una nostra e capiremo come valorizza il testo. Mostrerò anche esempi tratti dalla letteratura.
Che cos'è? Una metafora è una parola o una combinazione di parole usata in senso figurato. Lo scopo dell'utilizzo di una metafora è confrontare un nome, proprietà o valore senza nome di un oggetto con un altro oggetto, proprietà o valore, basato su caratteristiche simili. Non è così difficile come nella formulazione, quindi non aver paura.
Questo strumento linguistico viene spesso confuso con il confronto, ma la loro principale differenza è che al confronto è subito chiaro cosa e con cosa si sta confrontando, ad esempio "era bello come un fiore". Un esempio di metafora sarebbe semplicemente l'espressione "viola di una rosa". Tutti capiscono che la rosa non è viola, ma ha un colore brillante, simile a una lontana sfumatura di viola.
grande e potente
Oggi, nella moderna lingua letteraria russa, esiste un numero enorme di vari mezzi progettati per migliorare l'effetto. Tali mezzi sono chiamati tecniche artistiche e sono usati in tali stili di discorso:
Nella finzione, le frasi espressive sono usate per diluire il testo secco. In giornalismo - per aumentare l'effetto e l'impatto sul lettore, per fargli fare qualcosa, o almeno pensare al significato di ciò che ha letto.
Imparare a creare
Affinché tu possa creare una bella metafora, devi capire una regola: deve essere comprensibile alle masse. Cioè, deve essere compreso. Certo, ad alcune persone piace davvero pensare e indovinare cosa voleva davvero dire l'autore, ma questa è una piccola percentuale di lettori. La maggior parte desidera riconoscere qualcosa di familiare nel testo e associarsi a se stesso.
Avendo compreso la prima regola, vale anche la pena ricordare che nel linguaggio moderno esiste un numero enorme di cliché (frasi molto banali). Possono ferire molto gli occhi del lettore. Giudica tu stesso quanto sono stanche frasi come "amore per il male" e "acquista a buon mercato". Il primo è chiaro, ma il secondo è un cliché forzato che serve per ottimizzare il sito.
Spesso su tali siti non sarà possibile acquistare nulla di economico. Per quanto riguarda le metafore cliché, hanno un effetto doppiamente ripugnante. Ad esempio, "i tuoi occhi sono l'oceano" è una metafora che ha cento anni all'ora di pranzo. Non causerà al lettore alcun effetto diverso dal disgusto. Ricorda solo che non puoi usare espressioni lontane dal lettore e quelle di cui è già piuttosto stanco. Prova a trovare questa linea sottile e il tuo lavoro diventerà immediatamente più leggibile e interessante.

Classificazione
Oggi esistono diversi tipi di metafore:
- Sharp (riduce concetti di significato distante);
- Expanded (riunisce diversi concetti ed è incarnato in diverse parti del testo, ad esempio "il mercato dell'auto è caduto: i prodotti del mercato dell'auto sono sempre più stantii, non vuoi nemmeno assaggiarli");
- Erased (una metafora usata nella vita di tutti i giorni e già percepita come dovrebbe essere, ad esempio, una maniglia di una porta);
- Metafora-formula (vicino a cancellato, ma differisce in quanto le espressioni stabilite agiscono come unità fraseologiche - combinazioni indistruttibili di parole, ad esempio, un cuore d'oro).
Esempi dalla letteratura
I nostri grandi antenati ci hanno lasciato un enorme bagaglio di conoscenza crittografato nella letteratura, e solo coloro che possono comprendere tutte le idee dell'autore possono arrivare a questa conoscenza. Vale la pena iniziare la loro ricerca con il fatto che imparerai a comprendere i mezzi artistici che sono stati usati in letteratura. È anche necessario godersi veramente le opere e non leggere e dimenticare.
Visto che oggi parliamo di metafore, proviamo a capirle. Ad esempio, nella poesia di Sergei Yesenin "Non mi pento, non chiamo, non piango", la metafora "... oro appassito coperto ..." implica vicinanza alla vecchiaia. Se tu stesso ci hai già pensato, congratulazioni, puoi già identificare la metafora e, soprattutto, capirne il significato. Ma se conosci e comprendi questa caratteristica del linguaggio, non è affatto necessario che tu possa crearli tu stesso. Ciò richiede almeno un allenamento e, ancora meglio, una mente acuta. A proposito, "mente acuta" è anche una metafora per pensare fuori dagli schemi.
Si scopre che lo stile di comunicazione quotidiano implica anche la presenza di mezzi linguistici, ma qui la metafora è molto meno comune rispetto, ad esempio, a confronti o epiteti.
Grazie per aver letto fino alla fine, lascia il tuo commento e ottieni l'opportunità di scaricare un libro unico che ti aiuterà a diventare un vero autore.